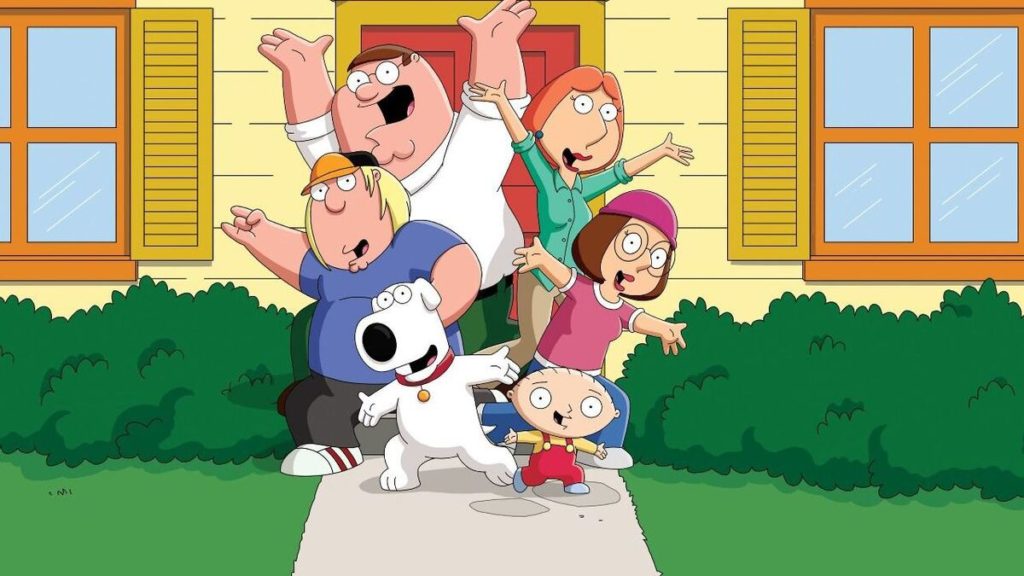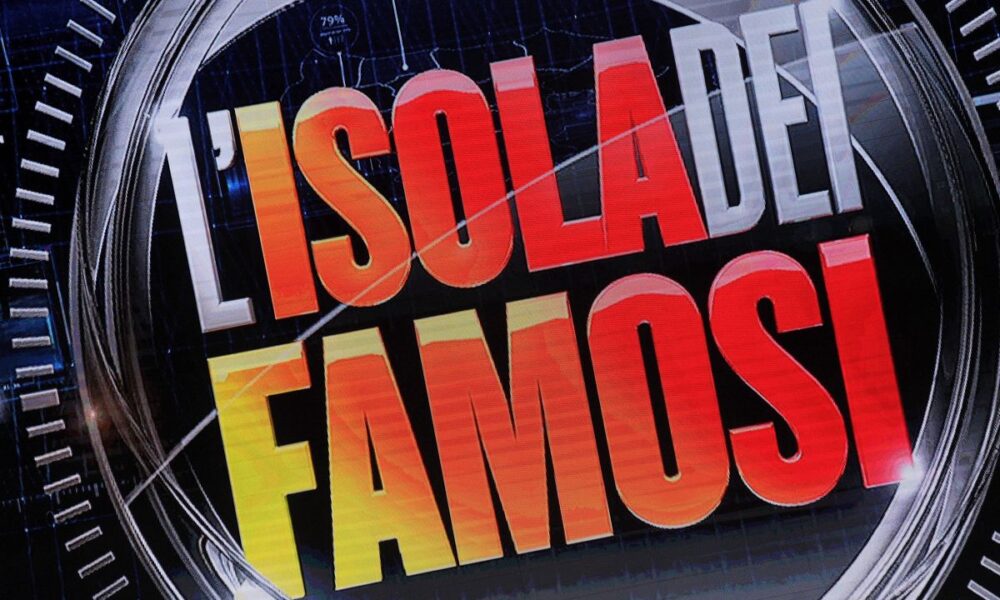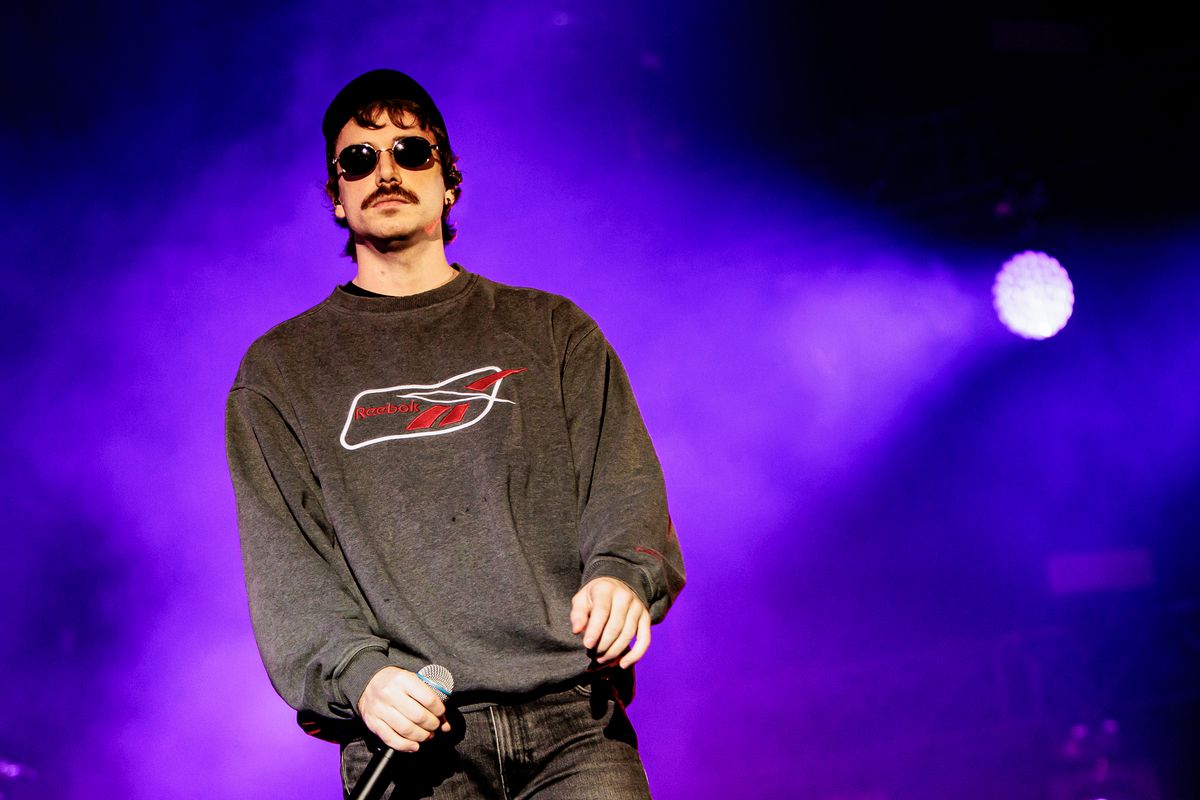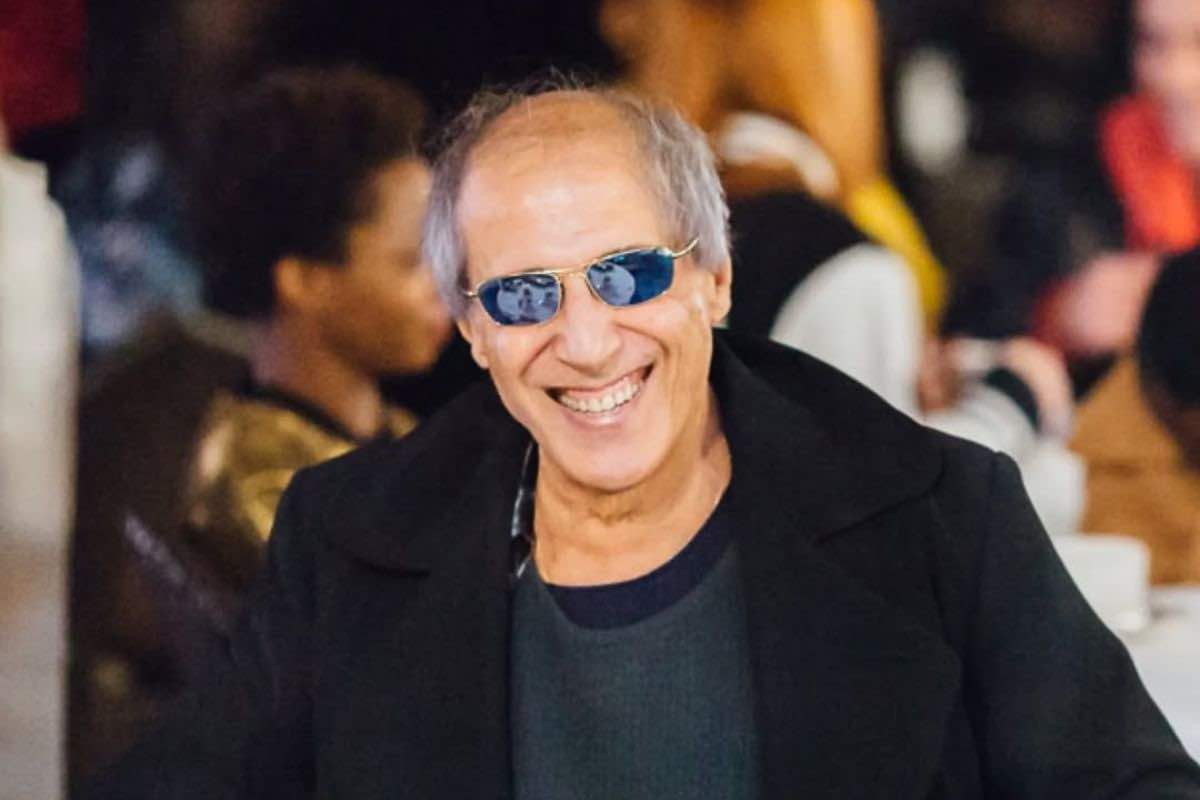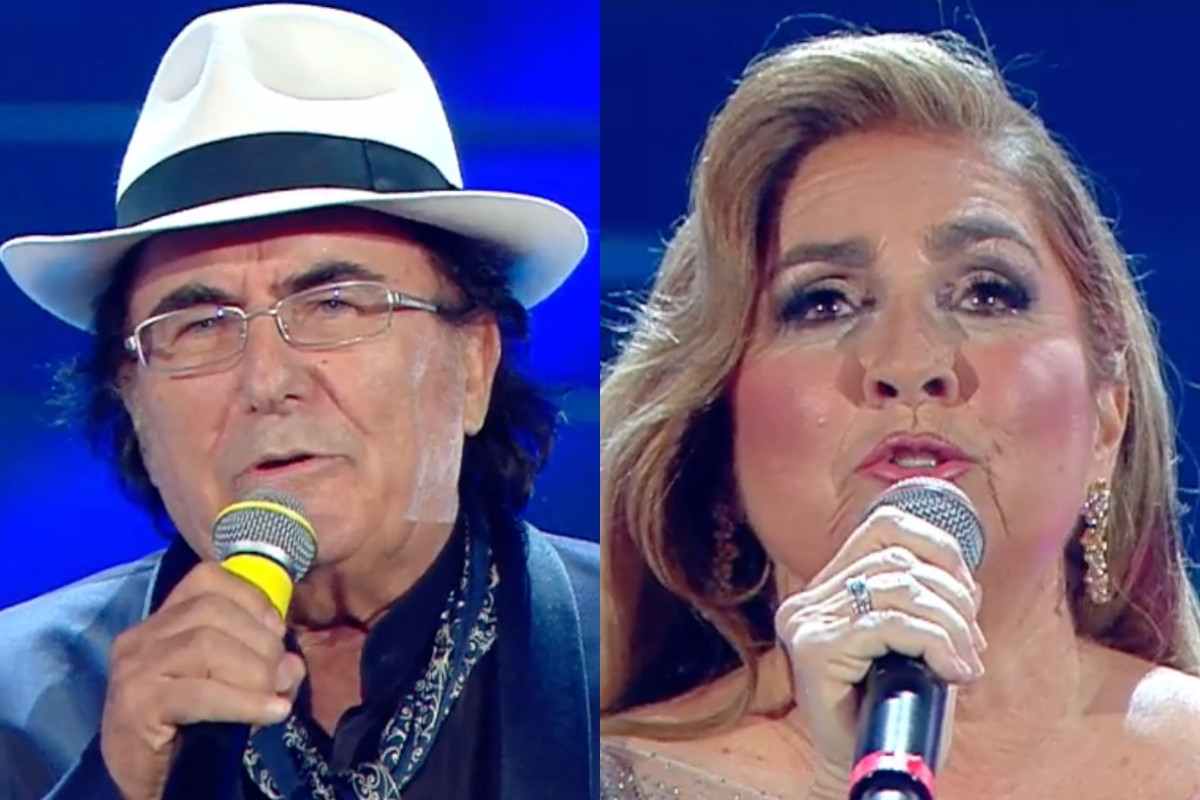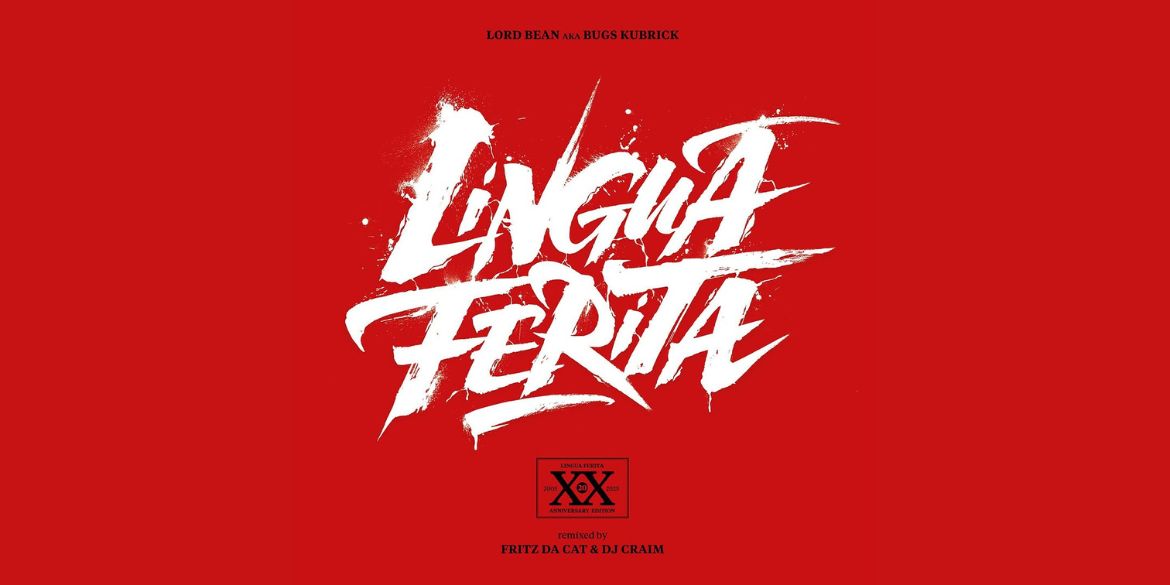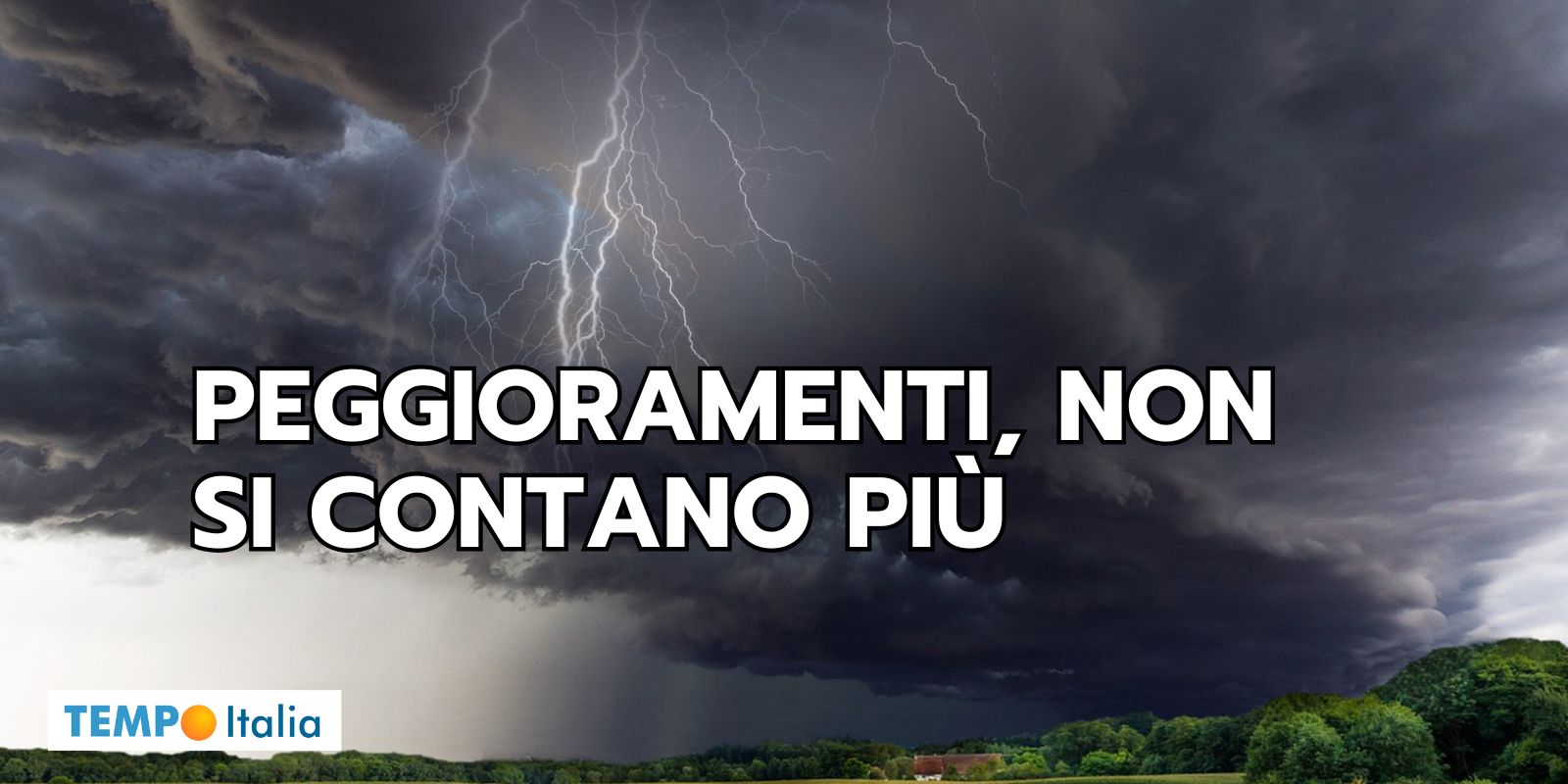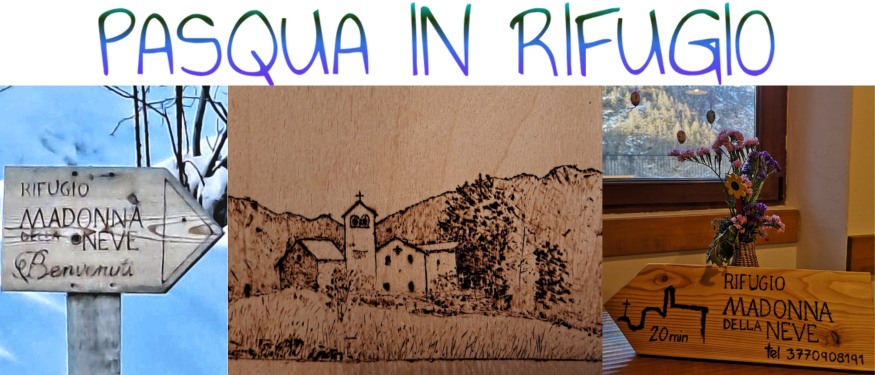La storia inedita delle traversate invernali del Gran Sasso
L’exploit di Hervé Barmasse il 6 e il 7 marzo scorsi ha riportato alla luce delle avventure dimenticate. I primi tentativi di traversata del massiccio e quello, riuscito, di Carlo Partiti e Lino Di Marcello nel 1997 L'articolo La storia inedita delle traversate invernali del Gran Sasso proviene da Montagna.TV.

Il 2 febbraio 1997, domenica, il tempo sul Gran Sasso è meraviglioso e gelido. Due alpinisti abruzzesi partono prima dell’alba dalla diga della Provvidenza, sulla vecchia statale che unisce Teramo con L’Aquila. S’incamminano per una strada sterrata, e dopo pochi minuti la neve ghiacciata li costringe a calzare i ramponi.
Quella di Carlo Partiti e Lino Di Marcello è una giornata epica. I due risalgono la Valle del Charino fino alla conca dove poi sorgerà il rifugio Fioretti; quindi, piegano a sinistra verso la cresta Ovest del Monte Corvo. Scavalcano i 2623 metri della vetta, scendono superando facili salti di rocce, e dalla conca del Venacquaro risalgono al Pizzo d’Intermesoli, 2635 metri. Dopo il tratto più ripido, a poche decine di metri dalla cima, il vento violentissimo rischia di farli rinunciare.
Una seconda discesa porta Lino e Carlo in Val Maone. Poi di nuovo su, verso il rifugio Garibaldi quasi nascosto dalla neve, la Sella del Brecciaio e la cresta Ovest del Corno Grande, che d’inverno offre dei tratti di misto. Dalla vetta più alta del Gran Sasso, 2912 metri, i due scendono per la Direttissima, scavalcano il Monte Aquila, raggiungono il piccolo rifugio D’Arcangelo, un ricovero di pastori sistemato dal CAI di Isola del Gran Sasso.
Riposano per quattro o cinque ore. Poi risalgono al Vado di Corno, e affrontano il Sentiero del Centenario, dieci chilometri di sviluppo, che in estate è un percorso di escursionismo impegnativo e d’inverno una grande course a saliscendi. Ma oggi non li ferma nessuno.
I due compiono l’intero percorso slegati, si sfidano a chi va più veloce, prima del Monte Prena compiono una vera e propria gara. Scavalcati anche i 2564 metri del Camicia scendono ancora sulla cresta e si tuffano nei ripidi valloni di Rigopiano. Prima di essere recuperati dagli amici al bivio per Arsita, camminano ancora a lungo, per una strada a mezza costa.
Un mese fa, il 6 e il 7 marzo, l’alpinista valdostano Hervé Barmasse compie una splendida traversata solitaria del Gran Sasso, alternando i ramponi agli sci. Diciassette vette oltre i 2000 metri di quota, 7200 metri di dislivello in salita, 67 chilometri. È una guida alpina del Cervino, è abituato alle grandi montagne valdostane e all’Himalaya, ma la bellezza e l’impegno del Gran Sasso lo stupiscono.
Hervé è un alpinista famoso, e il racconto e le immagini della sua traversata, diffuse sui giornali, sul web e dal programma Kilimangiaro di RaiTre fanno una straordinaria pubblicità al Gran Sasso e all’Abruzzo. Centinaia di escursionisti, alpinisti e scialpinisti di tutta l’Italia centrale lo ringraziano pubblicamente per questo.
L’exploit della guida valdostana, però, riporta alla luce una pagina di storia dell’esplorazione del Gran Sasso che è rimasta pressoché sconosciuta. Il Sentiero del Centenario, ideato, segnalato e attrezzato con poche decine di metri di corde e scale dalla Sezione dell’Aquila del CAI nel 1974 (l’anno del suo centenario, appunto) d’inverno offre una traversata interminabile e sostenuta, con passaggi ripidi, delicati ed esposti. Se la si inserisce in una traversata del massiccio dal Passo delle Capannelle o dalla Valle del Vomano fino a Fonte Vetica o a Rigopiano si ottiene una straordinaria avventura.
Non sappiamo se, oltre un secolo fa, qualche pioniere dell’alpinismo in Abruzzo pensi a tentare la traversata, che prima della costruzione (1934) della funivia di Campo Imperatore si svolge in un ambiente particolarmente remoto. Nei primi anni del Novecento, per compiere la prima invernale del Prena, una comitiva traversa l’altopiano innevato a cavallo, e prosegue a piedi, battendo pista, solo nel tratto finale.

Il primo tentativo invernale conosciuto del Centenario inizia sabato 13 febbraio 1982. Mario Cotogno, Bruno Tribioli, Luca Bucciarelli (che diventerà guida alpina) e Giampiero Pensalfine (che scomparirà tragicamente in Africa pochi anni dopo) partono con un bus di linea da Roma, raggiungono L’Aquila e poi Fonte Cerreto, salgono in funivia a Campo Imperatore e proseguono verso la cresta.
“In quegli anni eravamo estremamente allenati su quel tipo di terreno, l’auto era ancora un sogno, sapevamo di una perturbazione in arrivo da Ovest ma decidemmo di provare”, racconta oggi Mario Cotogno. Ma le cose non vanno così come sperato. Sul misto delle Torri di Casanova il fronte raggiunge gli alpinisti, dalla Forchetta di Santa Colomba i quattro affrontano un’interminabile discesa verso Isola del Gran Sasso.
Alla fine della discesa Luca e Giampiero trovano un passaggio per Roma, mentre Bruno e Mario bivaccano sotto alla pensilina di un distributore, e ripartono la mattina successiva. L’anno dopo, intorno a Capodanno, dal Duca degli Abruzzi, Cotogno e Angelo Monti salgono al Monte Aquila e scendono al Vado di Corno. La temperatura massima del giorno è di -18 gradi. Al Vado i due incontrano Luigi Benedetti, forte alpinista e compagno di cordata di Pierluigi Bini, che parte per un tentativo solitario al Centenario.
“Non è andata bene neanche a me” sorride oggi Benedetti. “Avrei dovuto tentare insieme a Giampaolo Picone, un altro compagno di Bini. Lui ha rinunciato per una pubalgia, io sono arrivato alle Torri di Casanova e ho fatto dietrofront per il maltempo. Ho bivaccato in una truna, gli scarponi di cuoio si sono gelati e non sono riuscito a chiuderli bene. Risultato? Dei congelamenti abbastanza seri, e una settimana all’ospedale dell’Aquila. Ma un’avventura che oggi racconto con orgoglio a mio figlio”.
Poi l’iniziativa passa agli abruzzesi. Nel 1996, con poca neve, Lino Di Marcello tenta da solo. Arriva sul Corno Grande, scivola per trenta metri dalle parti di Passo del Cannone, si ferma in un mucchio di neve prima di un volo che gli sarebbe costato la vita. Si vergogna a chiamare il soccorso, chiama Carlo, e questo lo raggiunge e torna a valle con lui. A gennaio del 1997, due settimane prima della traversata riuscita, i due tentano insieme, scavalcano Corvo e Intermesoli, poi la troppa neve fonda li costringe a scendere verso i Prati di Tivo.
Nel 1998, un anno dopo il successo, Lino e Carlo tentano la traversata in senso inverso, con Luigi De Angelis, Biagio Mengoli e Marco De Federicis. Salgono il Camicia per il ripido canale del Gravone, poi la troppa neve li costringe a rinunciare. Quel giorno De Angelis scatta a Partiti una foto che esce su Meridiani Montagne. Nel 2000 il gruppo ritenta senza Mengoli, ma il vento ferma il gruppo prima del Camicia. Dopo un bivacco in un’altra truna, si scende.
Uno o due inverni più tardi, arrivano sulla cresta Giampaolo Gioia e Leandro Giannangeli, due dei migliori alpinisti dell’Aquila. “Non ricordo se fosse il marzo del 2001 o del 2002, eravamo allenatissimi entrambi. Siamo partiti dalle Capannelle, e in due giorni siamo arrivati a Fonte Vetica. Una straordinaria esperienza, che poi è stata ripetuta da altri”, spiega Gioia, che da lì a poco salirà in bello stile il Cho Oyu. Leandro, da parte sua, diventerà una delle migliori guide alpine d’Abruzzo.
Resta da capire perché l’impresa compiuta da Partiti e da Di Marcello nel 1997 non sia stata conosciuta e applaudita come avrebbe certamente meritato. In parte è colpa degli storici dell’alpinismo sul Gran Sasso (incluso certamente chi scrive!), in parte delle logiche di un’epoca che non è poi così lontana, ma in cui Facebook e Instagram erano di là da venire.
“Abbiamo dato un appunto a un amico, speravamo che la facesse pubblicare sul Bollettino del CAI dell’Aquila” sorride oggi Carlo Partiti. “Non so cosa sia successo, la notizia non è uscita, la nostra grande avventura è rimasta un segreto per pochi amici”. Anche grazie a Hervé Barmasse, il momento di raccontarla è arrivato.
L'articolo La storia inedita delle traversate invernali del Gran Sasso proviene da Montagna.TV.












































































































![I metalupi di Game of Thrones esistono davvero: una start-up li ha riportati in vita dopo più di 10.000 anni [FOTO]](https://www.hallofseries.com/wp-content/uploads/2025/04/Jon-Snow-e-il-metalupo-Spettro-Game-of-Thrones-1024x576.png?#)