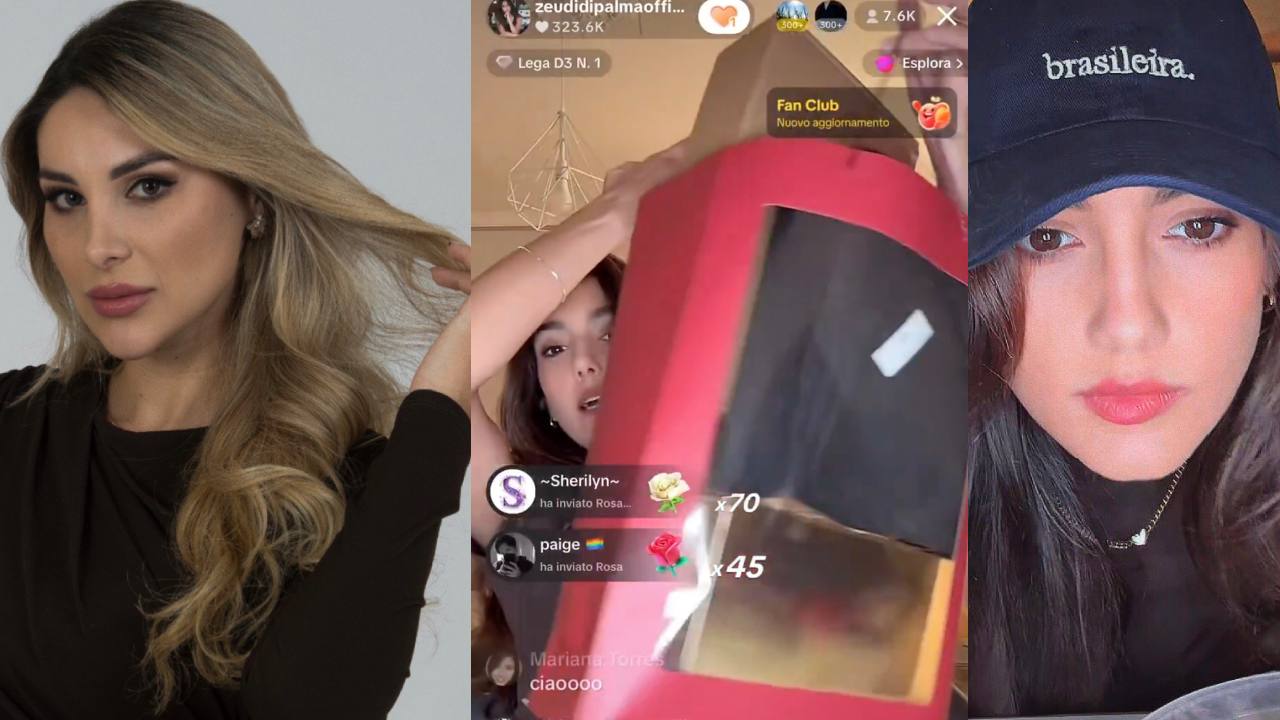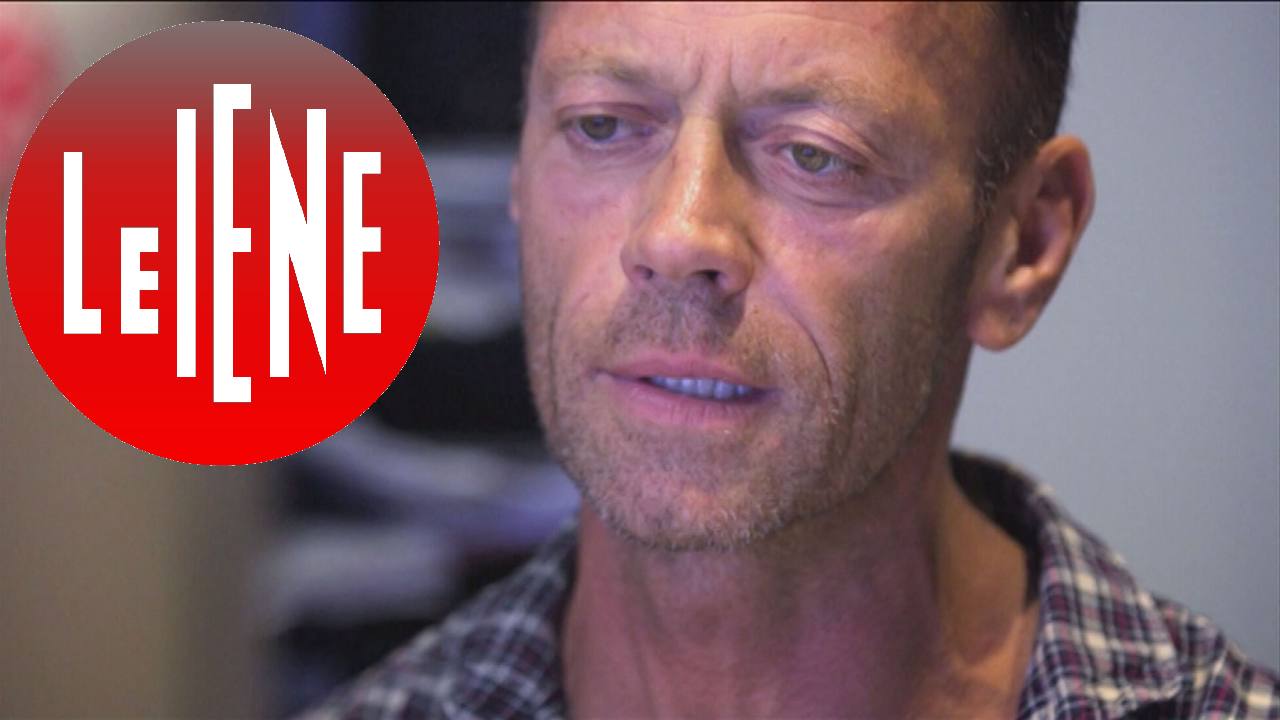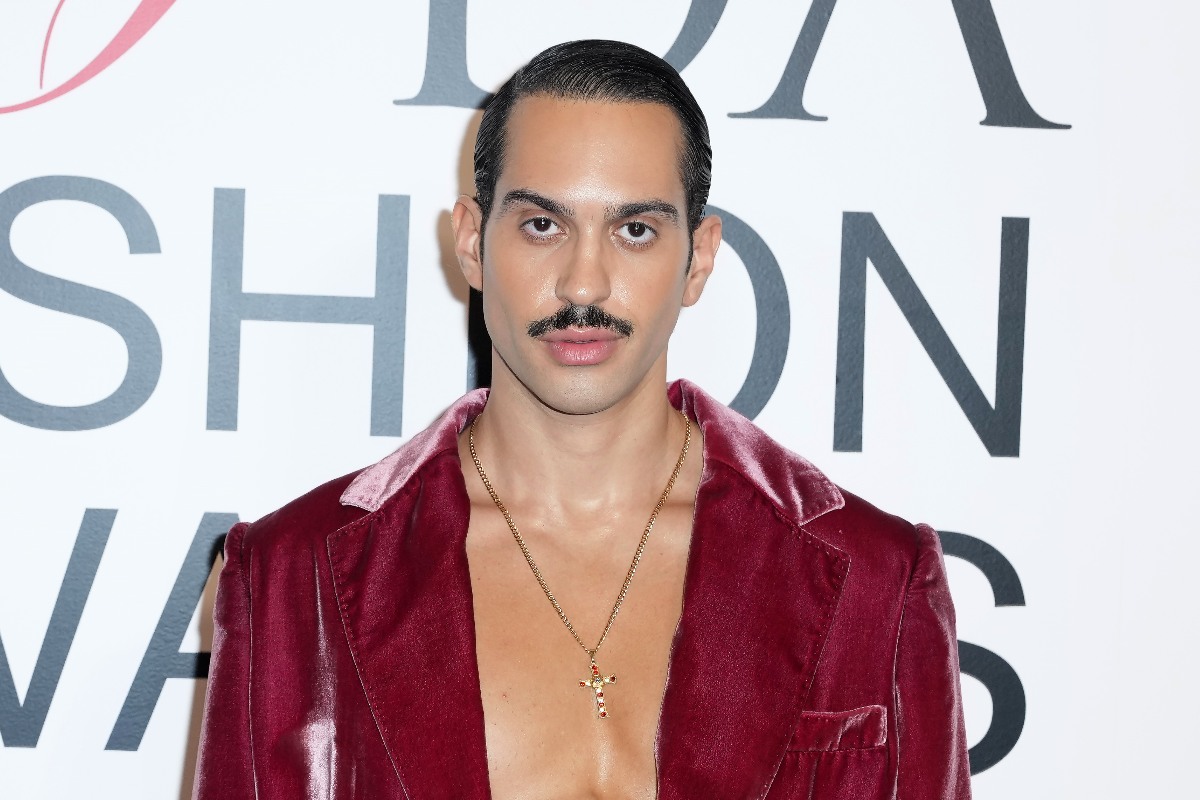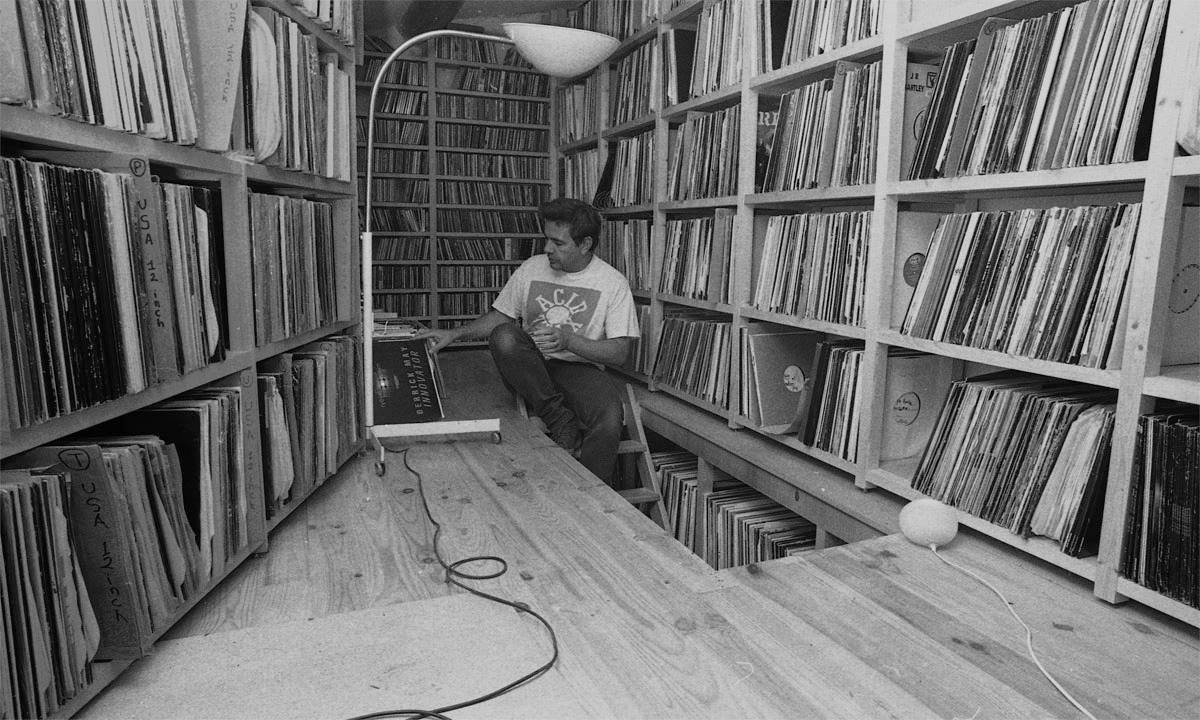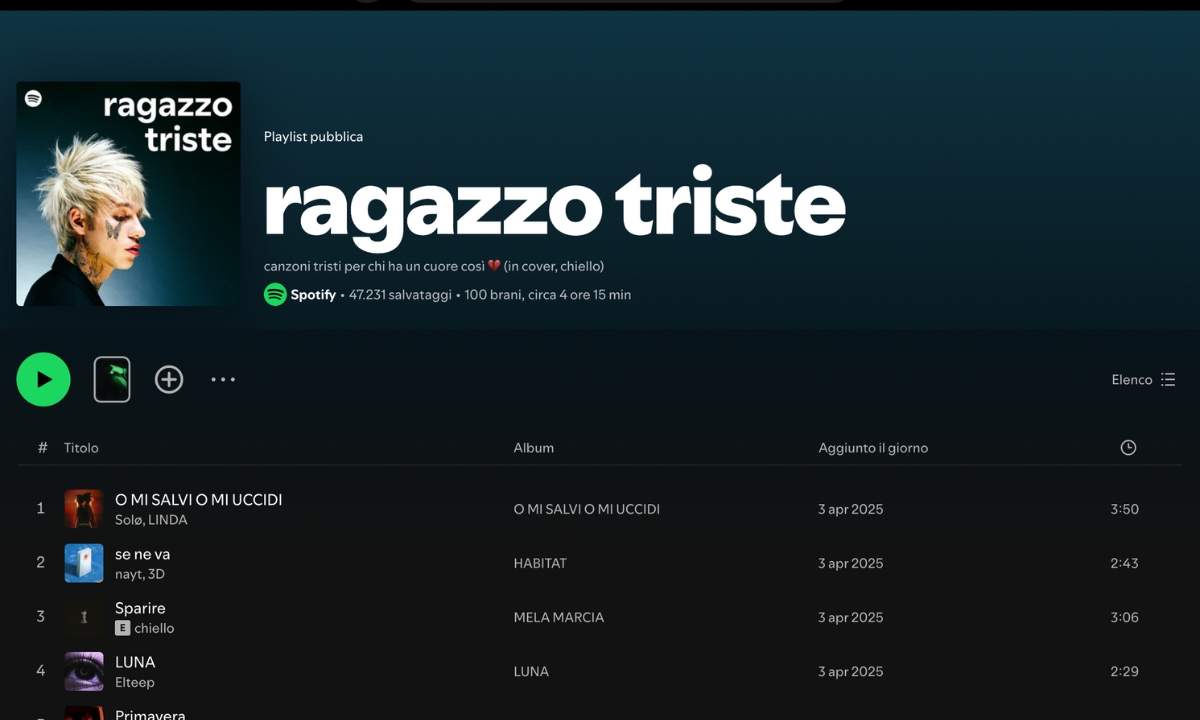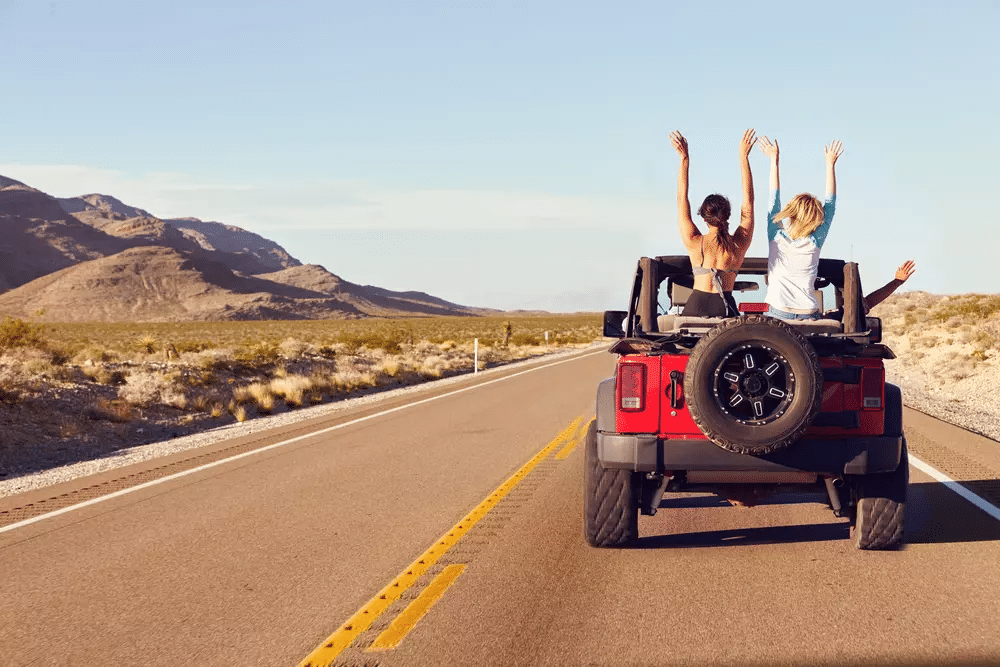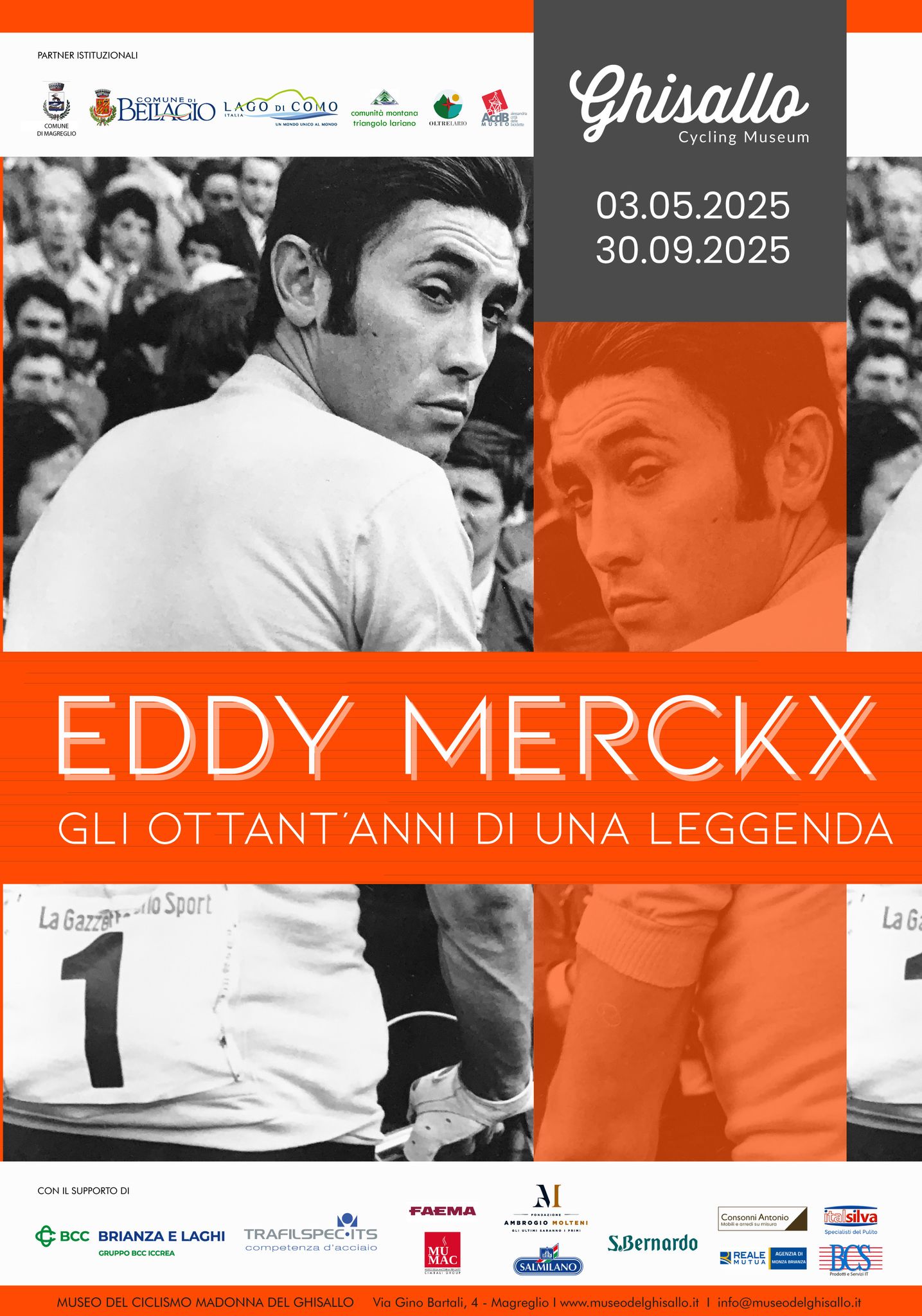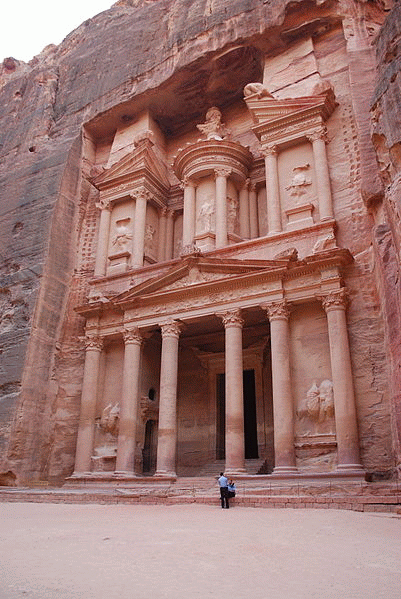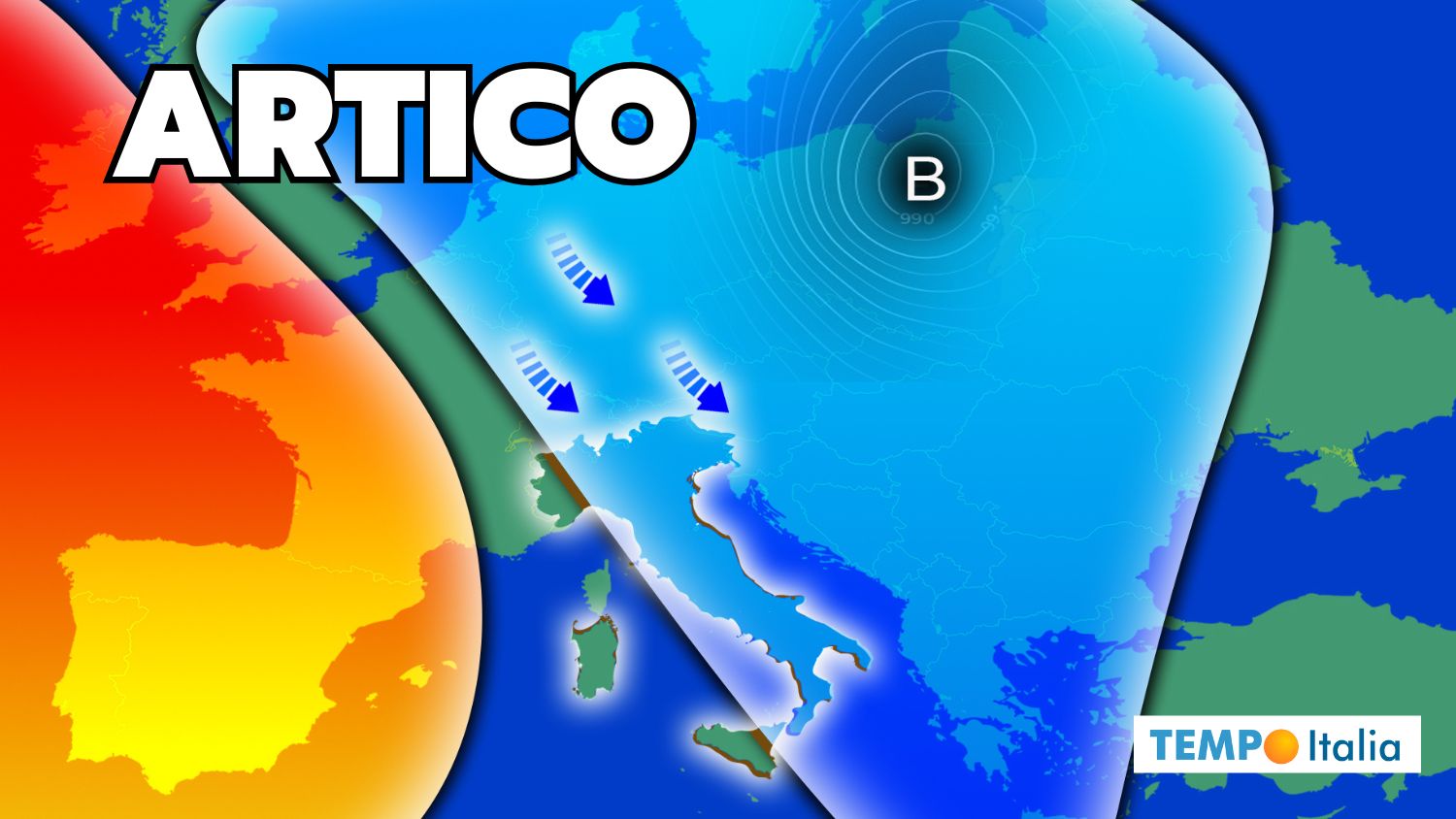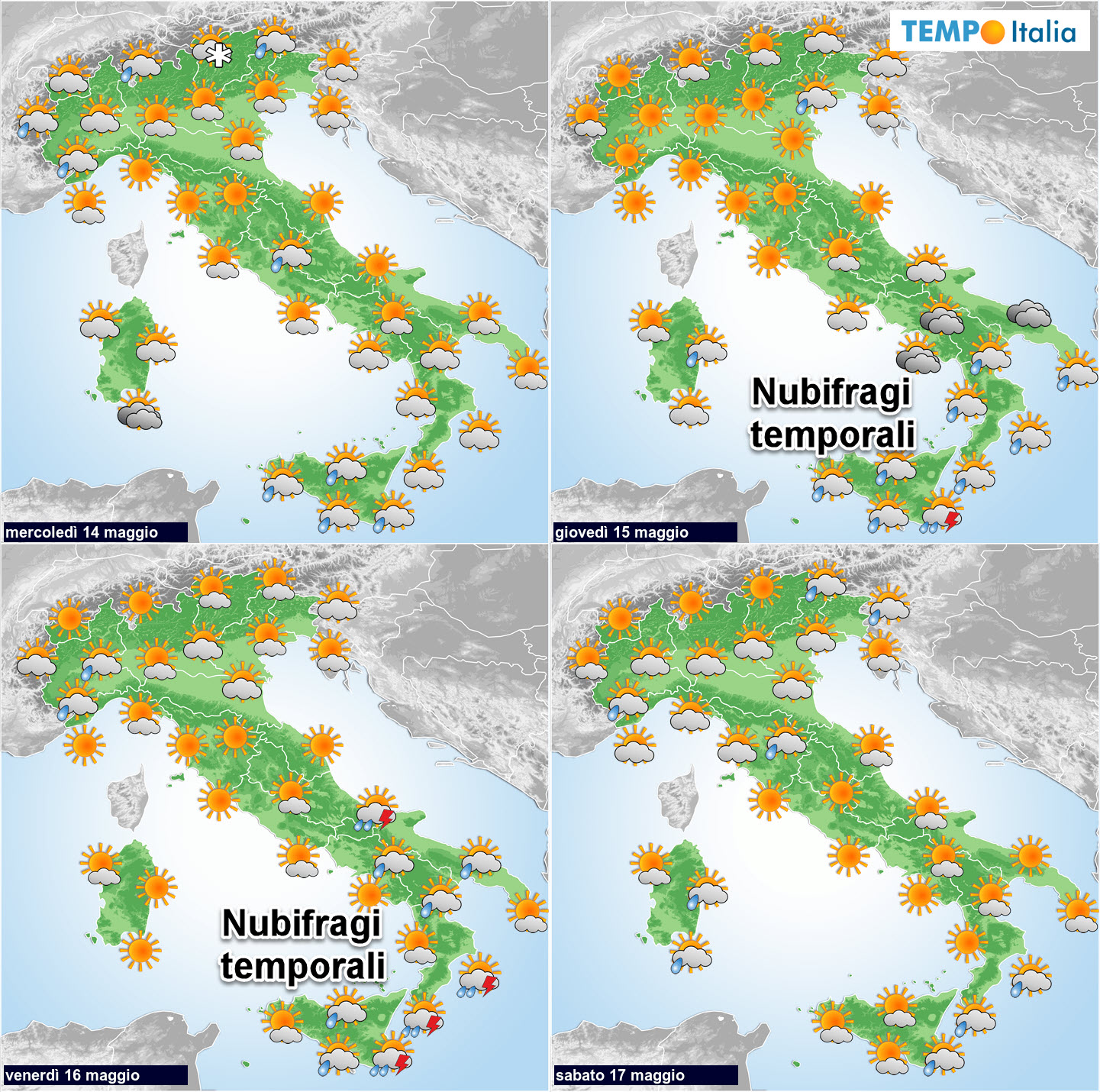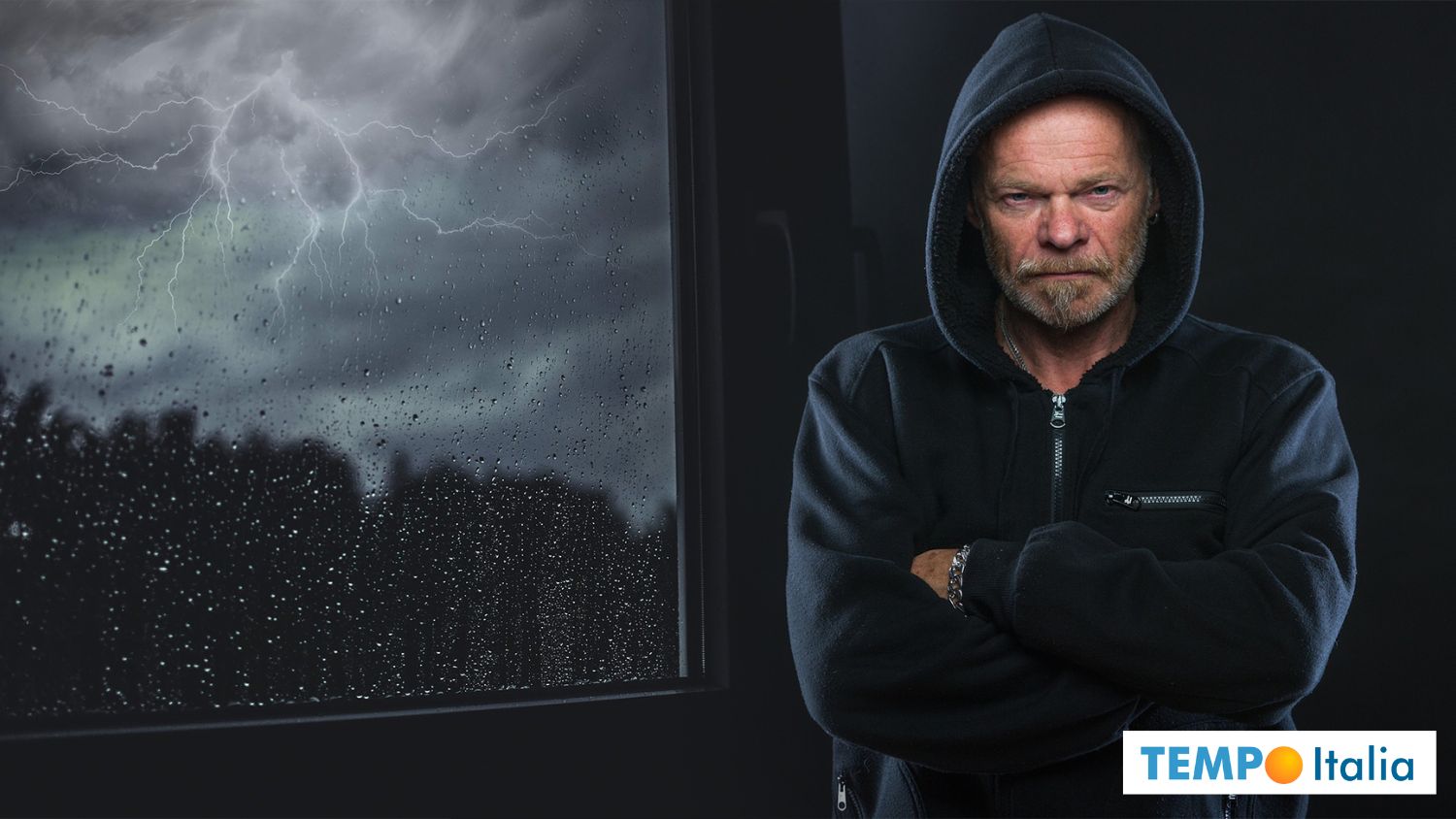Il Vesuvio: future eruzioni del “vulcano” tra i più cattivi al Mondo
Un gigante dormiente alle porte di Napoli Il Vesuvio, maestoso e inquietante al tempo stesso, domina il paesaggio della Campania e dell’intera area metropolitana di Napoli. È uno dei pochi vulcani attivi dell’Europa continentale e tra i più pericolosi del pianeta, non solo per la sua potenza distruttiva, ma anche per l’elevatissima densità abitativa che […] Il Vesuvio: future eruzioni del “vulcano” tra i più cattivi al Mondo


 Un gigante dormiente alle porte di Napoli Il Vesuvio, maestoso e inquietante al tempo stesso, domina il paesaggio della Campania e dell’intera area metropolitana di Napoli. È uno dei pochi vulcani attivi dell’Europa continentale e tra i più pericolosi del pianeta, non solo per la sua potenza distruttiva, ma anche per l’elevatissima densità abitativa che lo circonda. La sua attività ha segnato profondamente la storia geologica e culturale del bacino del Mediterraneo, rendendolo uno dei soggetti più studiati dalla vulcanologia moderna.
Un gigante dormiente alle porte di Napoli Il Vesuvio, maestoso e inquietante al tempo stesso, domina il paesaggio della Campania e dell’intera area metropolitana di Napoli. È uno dei pochi vulcani attivi dell’Europa continentale e tra i più pericolosi del pianeta, non solo per la sua potenza distruttiva, ma anche per l’elevatissima densità abitativa che lo circonda. La sua attività ha segnato profondamente la storia geologica e culturale del bacino del Mediterraneo, rendendolo uno dei soggetti più studiati dalla vulcanologia moderna.  L’eruzione del 79 d.C. L’evento che ha cristallizzato il Vesuvio nell’immaginario collettivo mondiale è senza dubbio l’eruzione del 79 d.C., narrata con drammatica precisione dallo scrittore romano Plinio il Giovane. In quell’occasione, una colonna eruttiva alta oltre 30 chilometri si innalzò nel cielo, riversando su Pompei, Ercolano e Stabiae una pioggia letale di cenere e lapilli, seguita da ondate piroclastiche incandescenti che cancellarono intere comunità. Questo evento ha dato origine al termine “eruzione pliniana”, oggi usato in vulcanologia per descrivere eruzioni esplosive di simile intensità (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377027308003290). Attività eruttiva tra XVII e XX secolo Dopo un lungo periodo di quiescenza durato più di un millennio, il Vesuvio si risvegliò nel 1631, dando vita a un’eruzione devastante che causò la morte di circa 4000 persone e la distruzione di numerosi centri abitati. Da quell’anno e fino al 1944, il vulcano ha vissuto una fase di attività persistente, con eruzioni di intensità variabile quasi ogni decennio. L’ultima eruzione risale al marzo 1944. In pieno contesto bellico, mentre gli alleati erano presenti nella regione, il Vesuvio emise lava e ceneri che distrussero i paesi di San Sebastiano, Massa di Somma e Cercola. Morirono 26 persone e diversi aerei dell’aviazione americana furono danneggiati dalla caduta di materiale vulcanico sull’aeroporto di Capodichino. Da allora, il Vesuvio è entrato in uno stato di quiescenza che si protrae da oltre 80 anni: uno dei più lunghi nella sua storia documentata. Monitoraggio e sorveglianza Il Vesuvio è oggi uno dei vulcani più monitorati al mondo, grazie all’attività dell’Osservatorio Vesuviano, fondato nel 1841 e attualmente parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La rete di sorveglianza utilizza una fitta maglia di strumenti che rilevano in tempo reale parametri geofisici e geochimici:
L’eruzione del 79 d.C. L’evento che ha cristallizzato il Vesuvio nell’immaginario collettivo mondiale è senza dubbio l’eruzione del 79 d.C., narrata con drammatica precisione dallo scrittore romano Plinio il Giovane. In quell’occasione, una colonna eruttiva alta oltre 30 chilometri si innalzò nel cielo, riversando su Pompei, Ercolano e Stabiae una pioggia letale di cenere e lapilli, seguita da ondate piroclastiche incandescenti che cancellarono intere comunità. Questo evento ha dato origine al termine “eruzione pliniana”, oggi usato in vulcanologia per descrivere eruzioni esplosive di simile intensità (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377027308003290). Attività eruttiva tra XVII e XX secolo Dopo un lungo periodo di quiescenza durato più di un millennio, il Vesuvio si risvegliò nel 1631, dando vita a un’eruzione devastante che causò la morte di circa 4000 persone e la distruzione di numerosi centri abitati. Da quell’anno e fino al 1944, il vulcano ha vissuto una fase di attività persistente, con eruzioni di intensità variabile quasi ogni decennio. L’ultima eruzione risale al marzo 1944. In pieno contesto bellico, mentre gli alleati erano presenti nella regione, il Vesuvio emise lava e ceneri che distrussero i paesi di San Sebastiano, Massa di Somma e Cercola. Morirono 26 persone e diversi aerei dell’aviazione americana furono danneggiati dalla caduta di materiale vulcanico sull’aeroporto di Capodichino. Da allora, il Vesuvio è entrato in uno stato di quiescenza che si protrae da oltre 80 anni: uno dei più lunghi nella sua storia documentata. Monitoraggio e sorveglianza Il Vesuvio è oggi uno dei vulcani più monitorati al mondo, grazie all’attività dell’Osservatorio Vesuviano, fondato nel 1841 e attualmente parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La rete di sorveglianza utilizza una fitta maglia di strumenti che rilevano in tempo reale parametri geofisici e geochimici: - Sismicità locale e profonda
- Deformazioni del suolo attraverso GPS e tiltmetri
- Flussi di gas (CO₂, SO₂) dalle fumarole
- Composizione chimica delle acque sotterranee
- Variazioni gravitazionali e magnetiche
- Incremento del numero e dell’energia dei terremoti locali
- Sollevamento del suolo misurabile in centimetri o decimetri
- Modificazioni nella composizione dei gas emessi
- Aumento della temperatura delle acque termali
- Formazione di nuove fratture e fumarole
Il Vesuvio: future eruzioni del “vulcano” tra i più cattivi al Mondo
















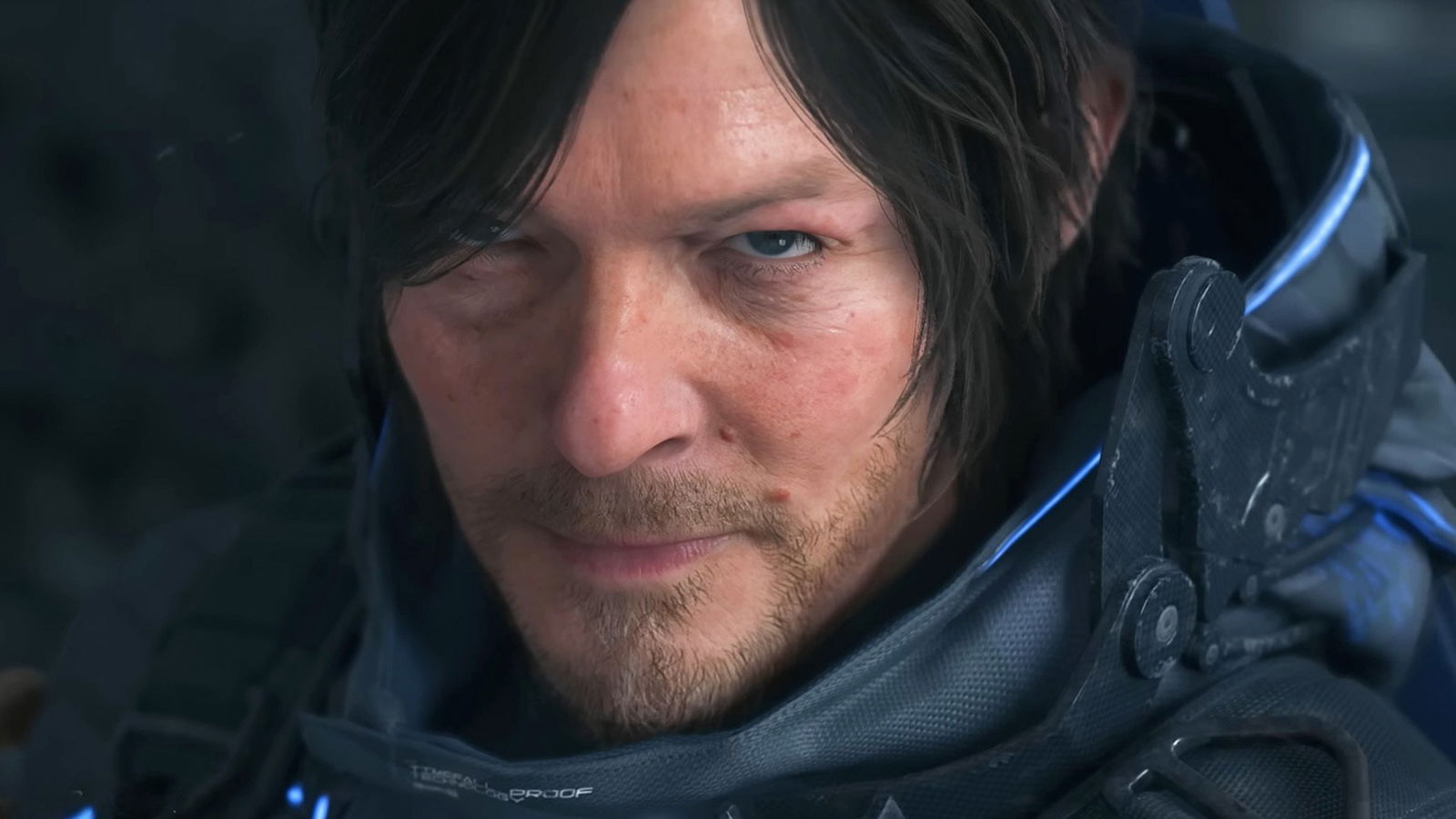












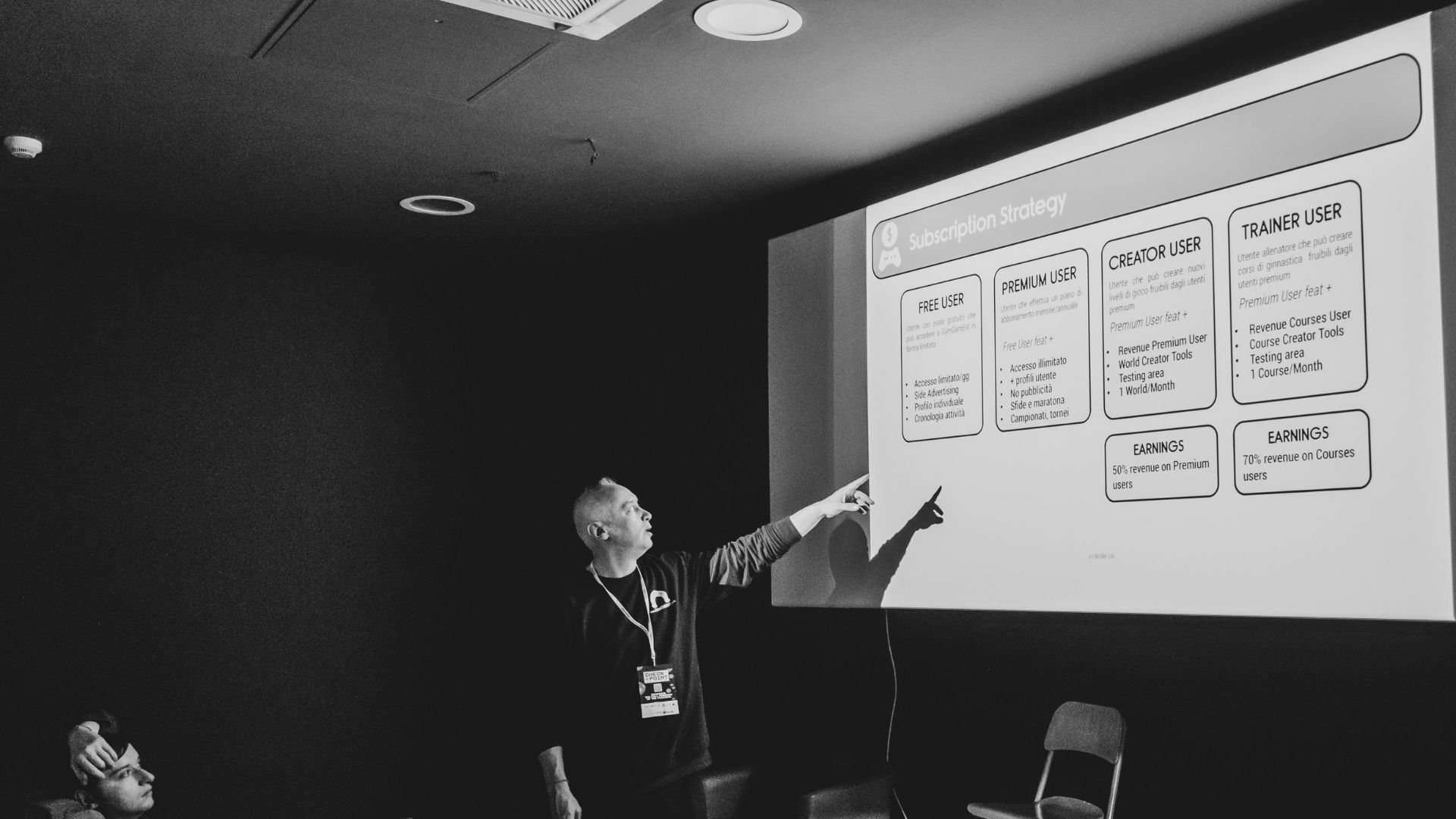
































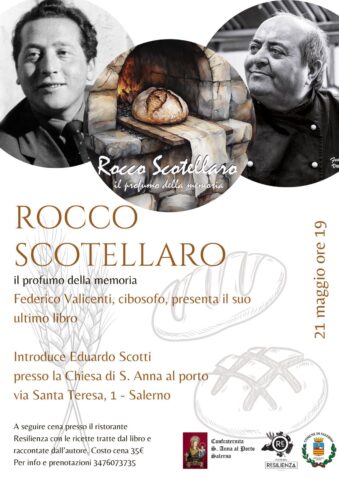





















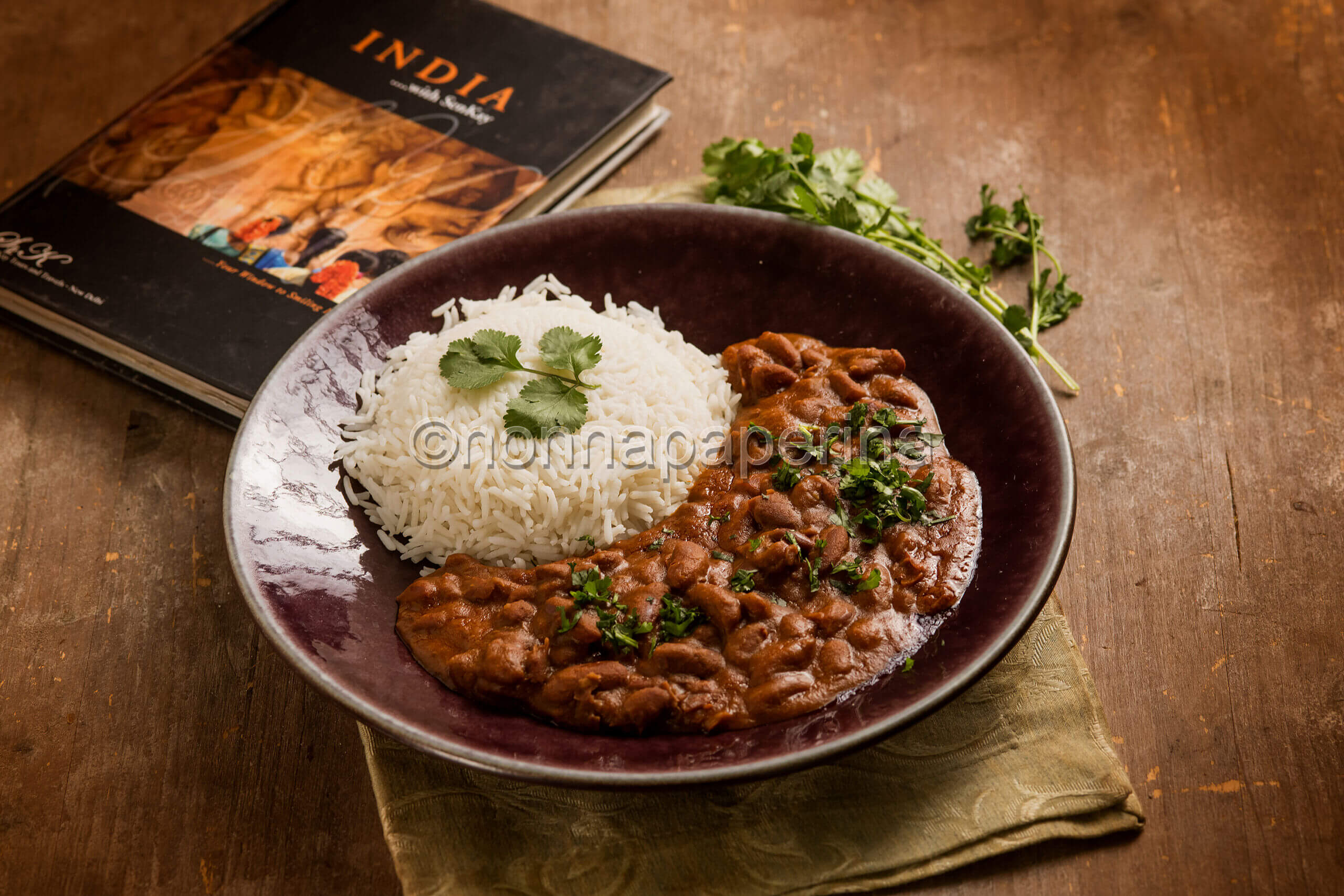


































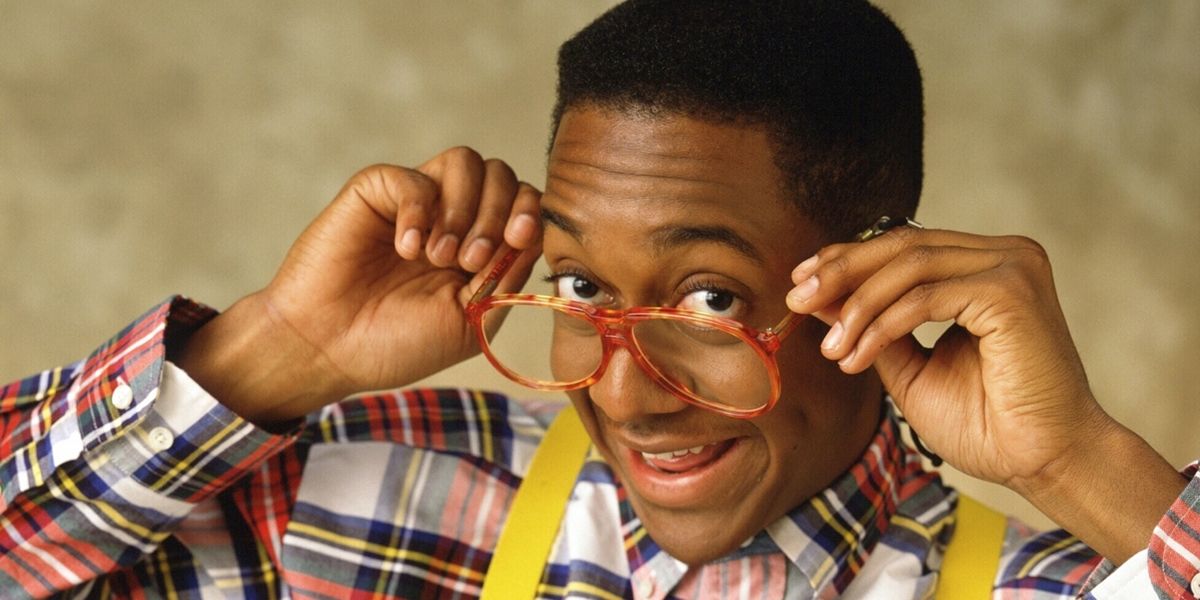
























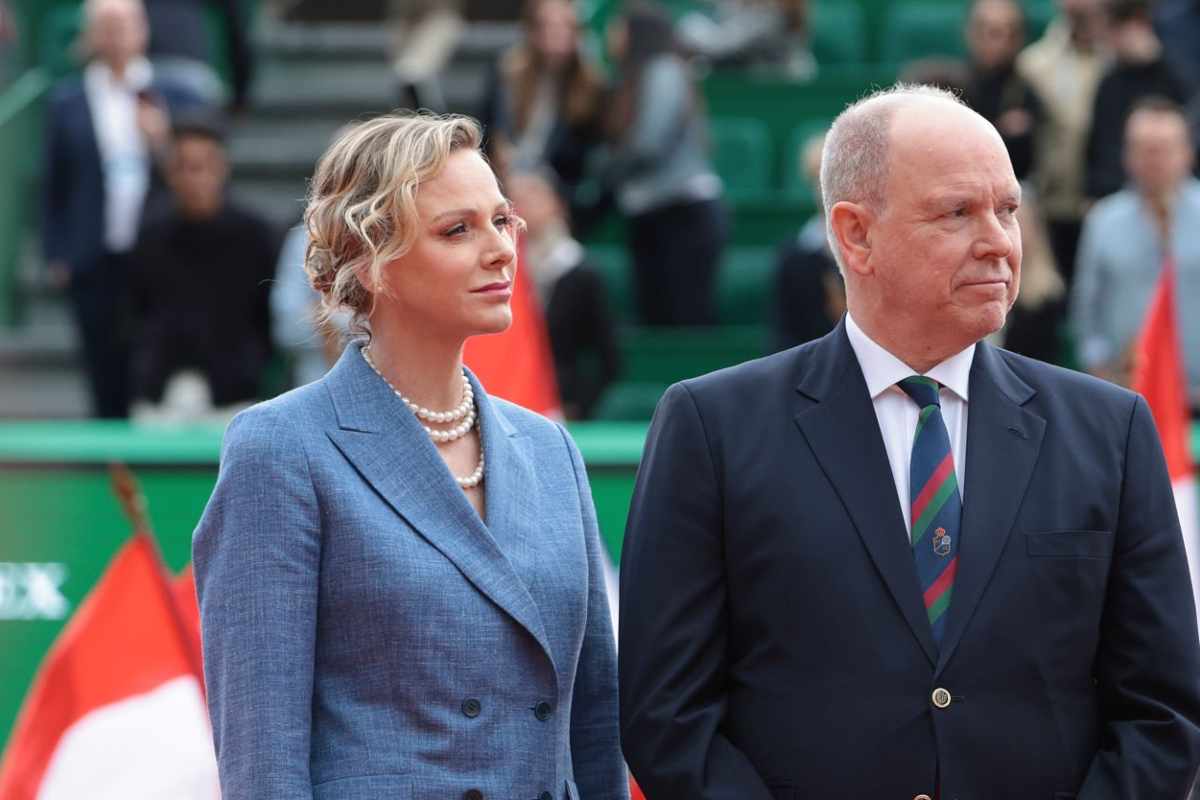



![The Office: la prima immagine di The Paper, il sequel/spin-off con Domhnall Gleeson [FOTO]](https://www.lascimmiapensa.com/wp-content/uploads/2025/05/image-112.png)