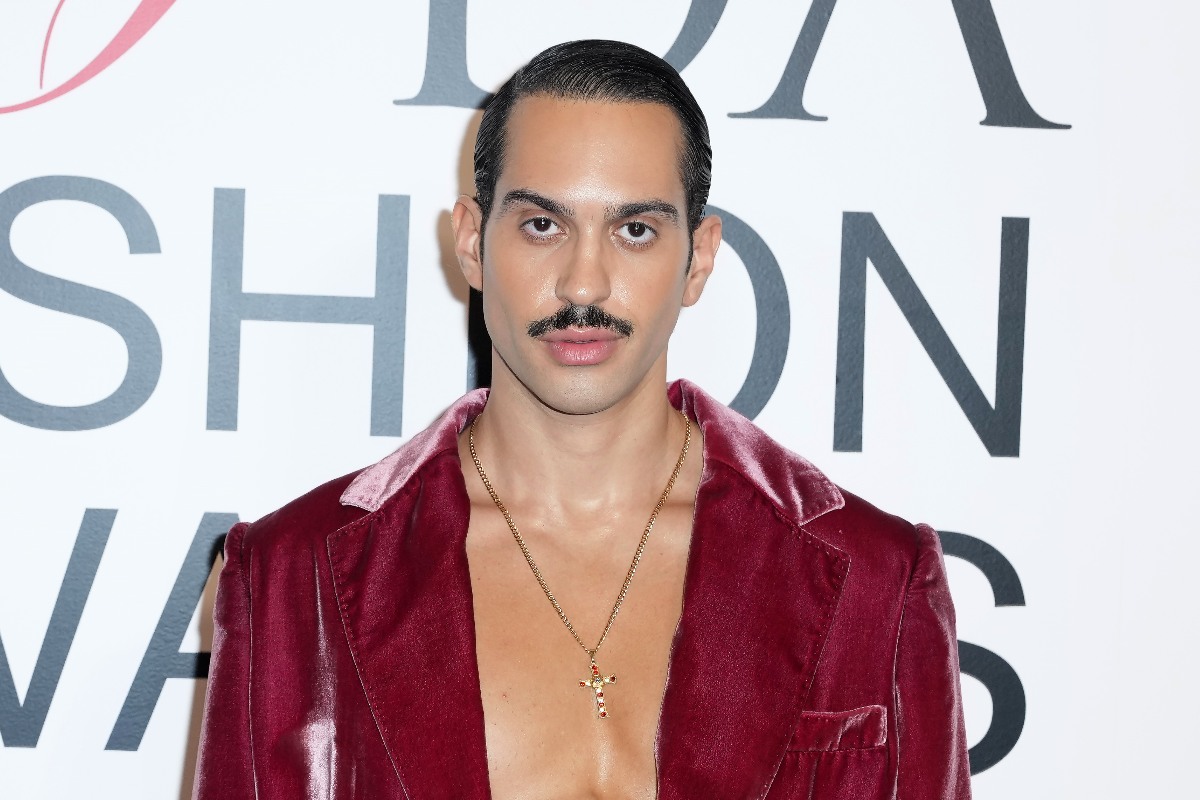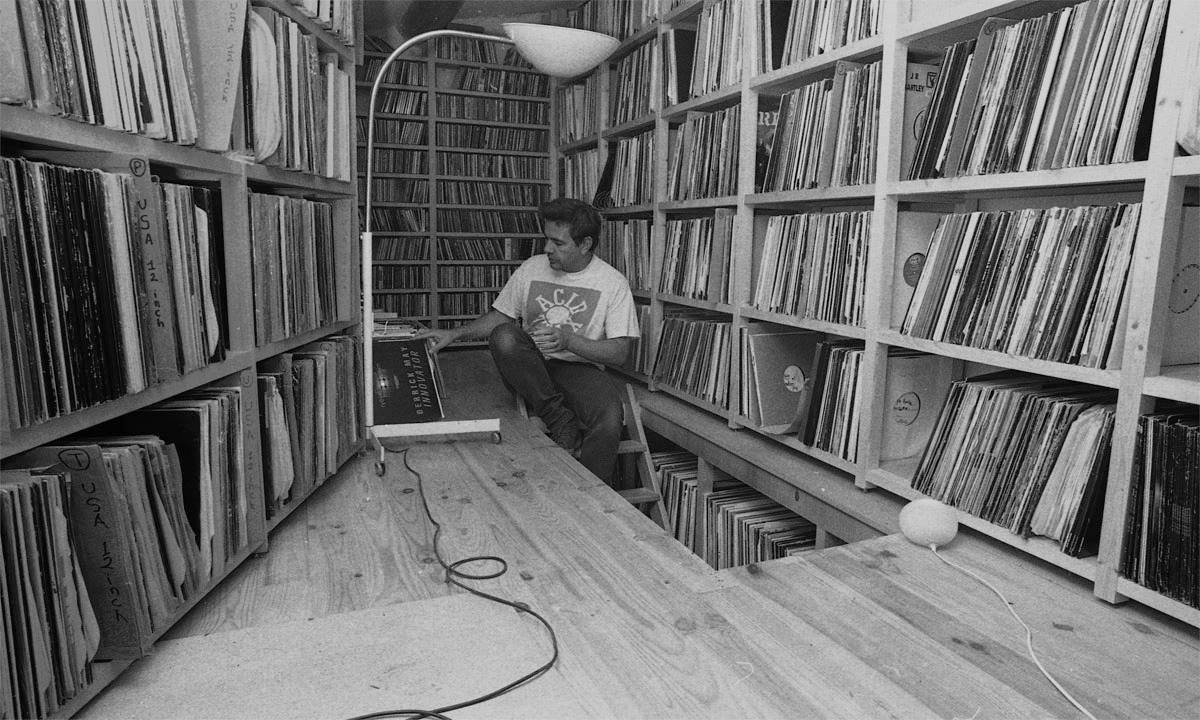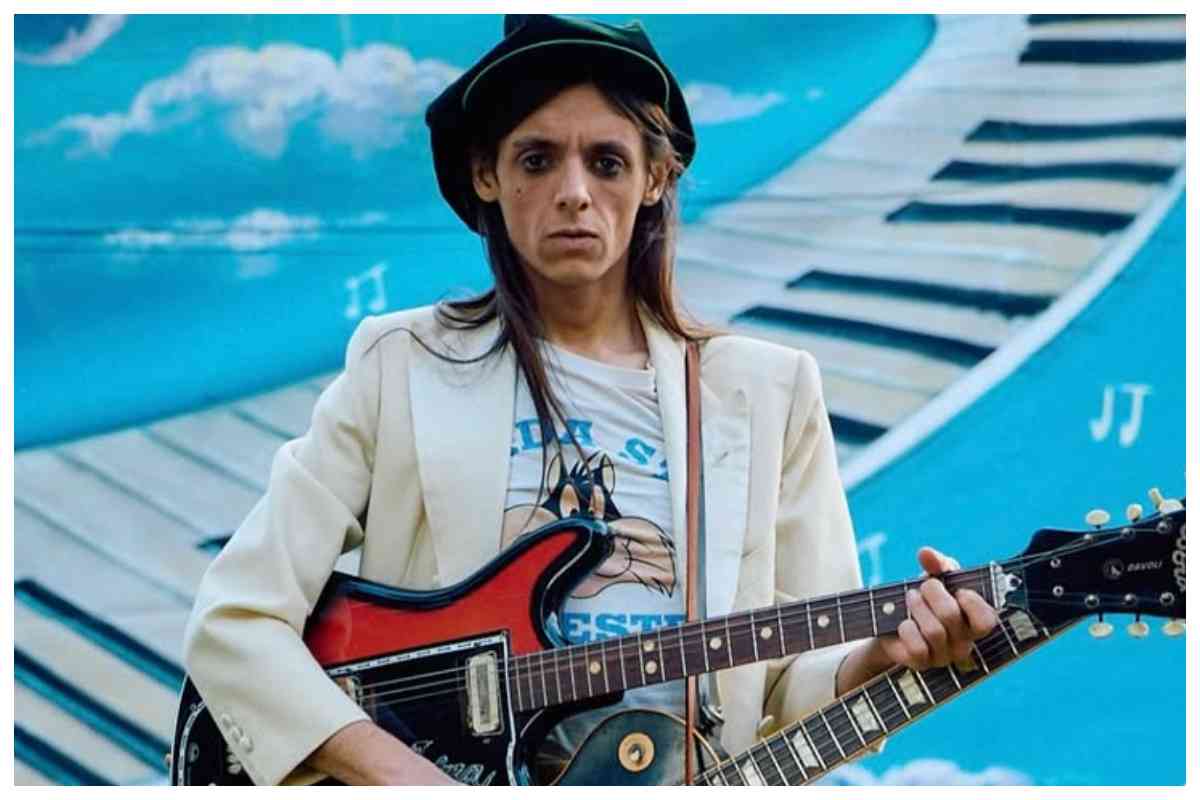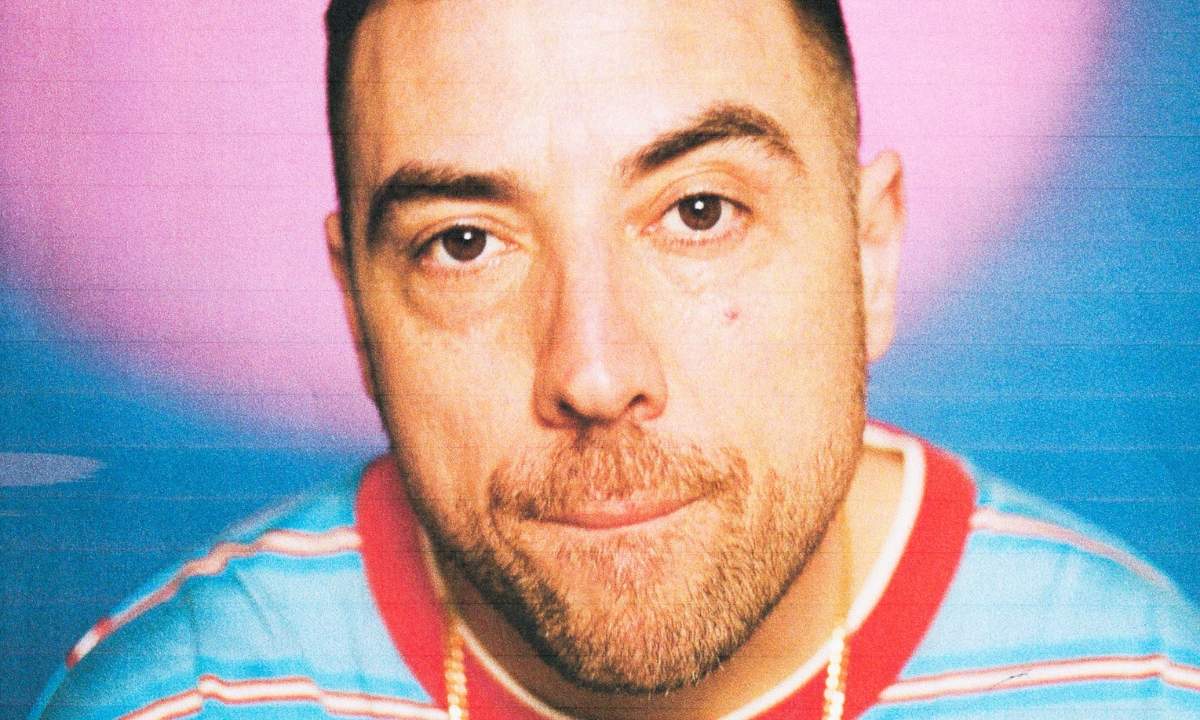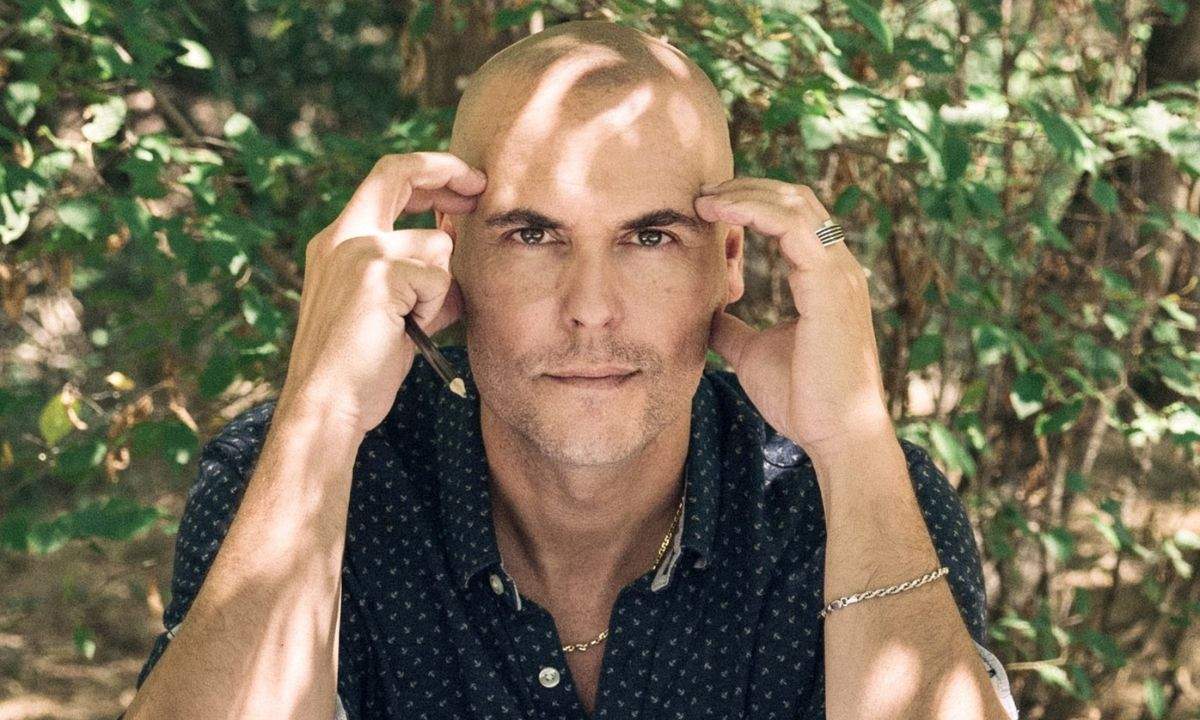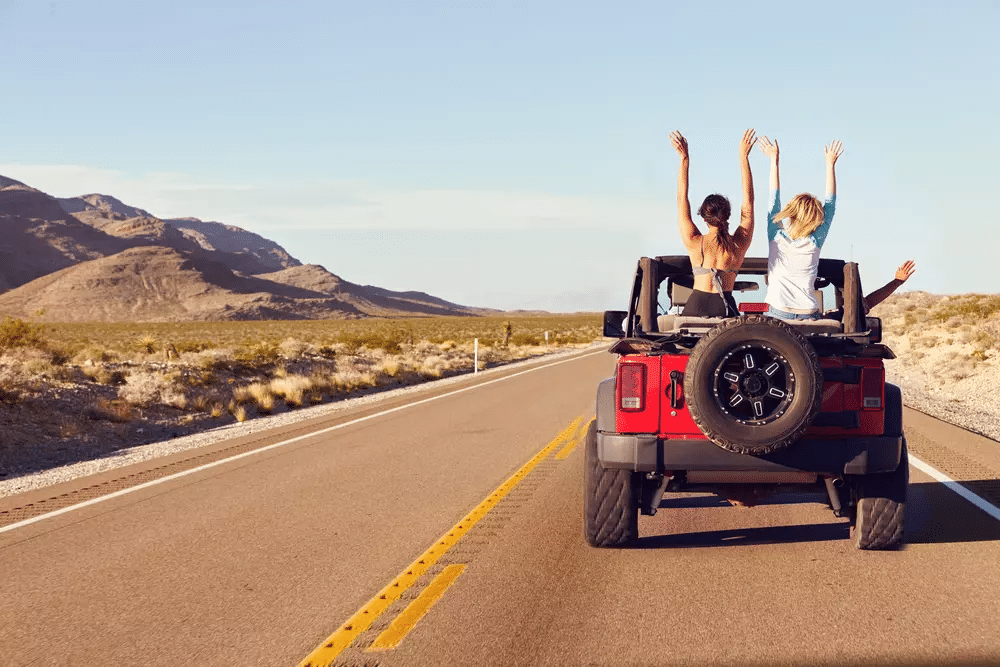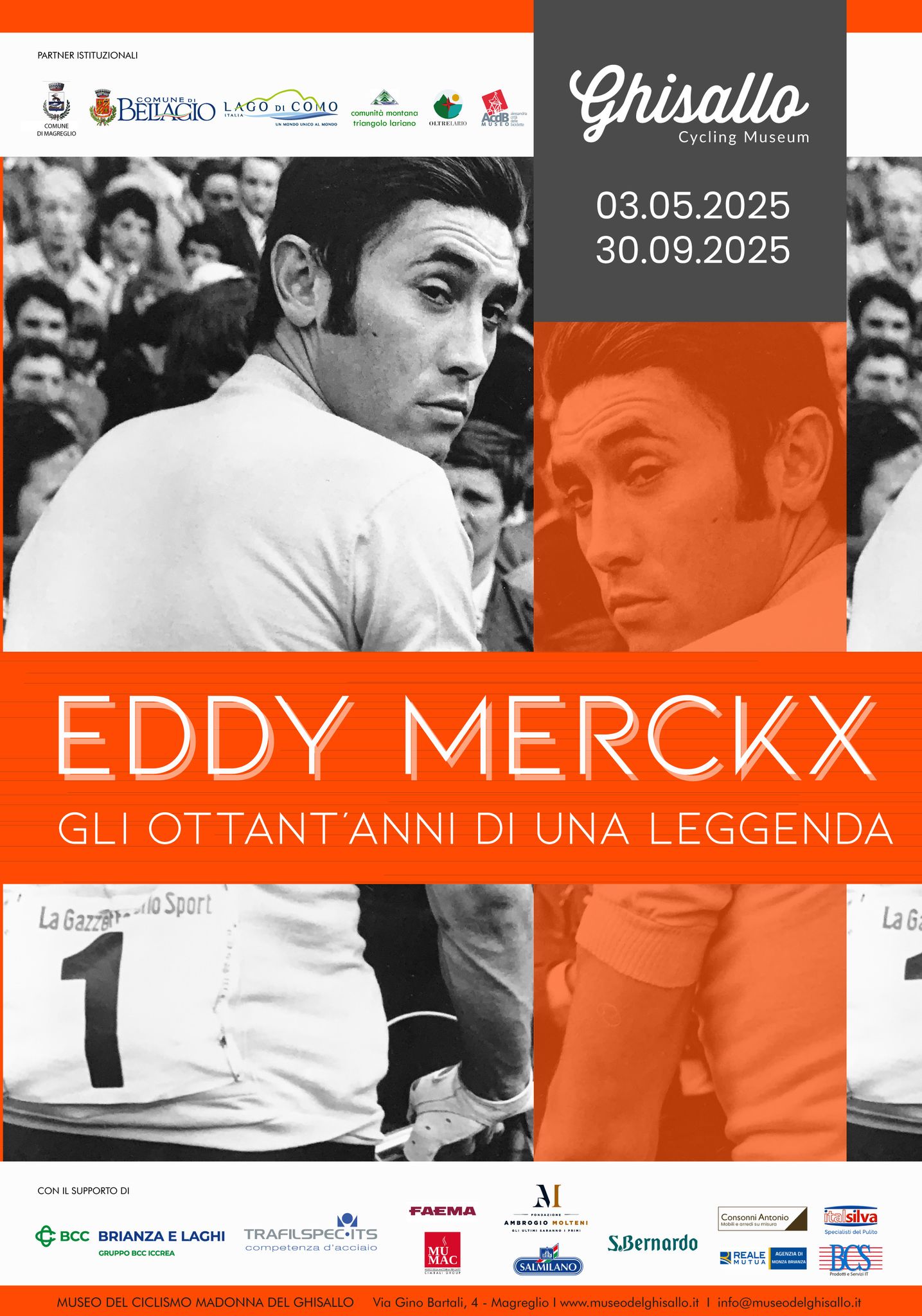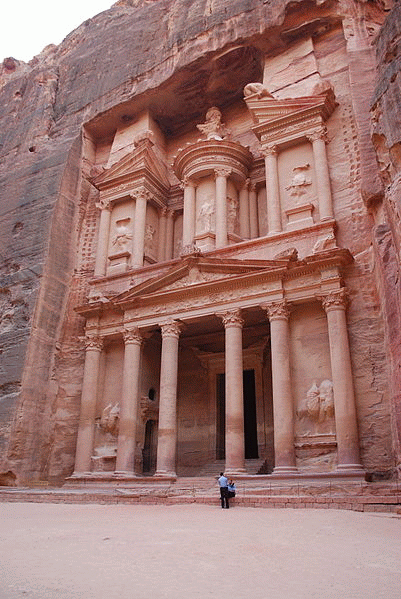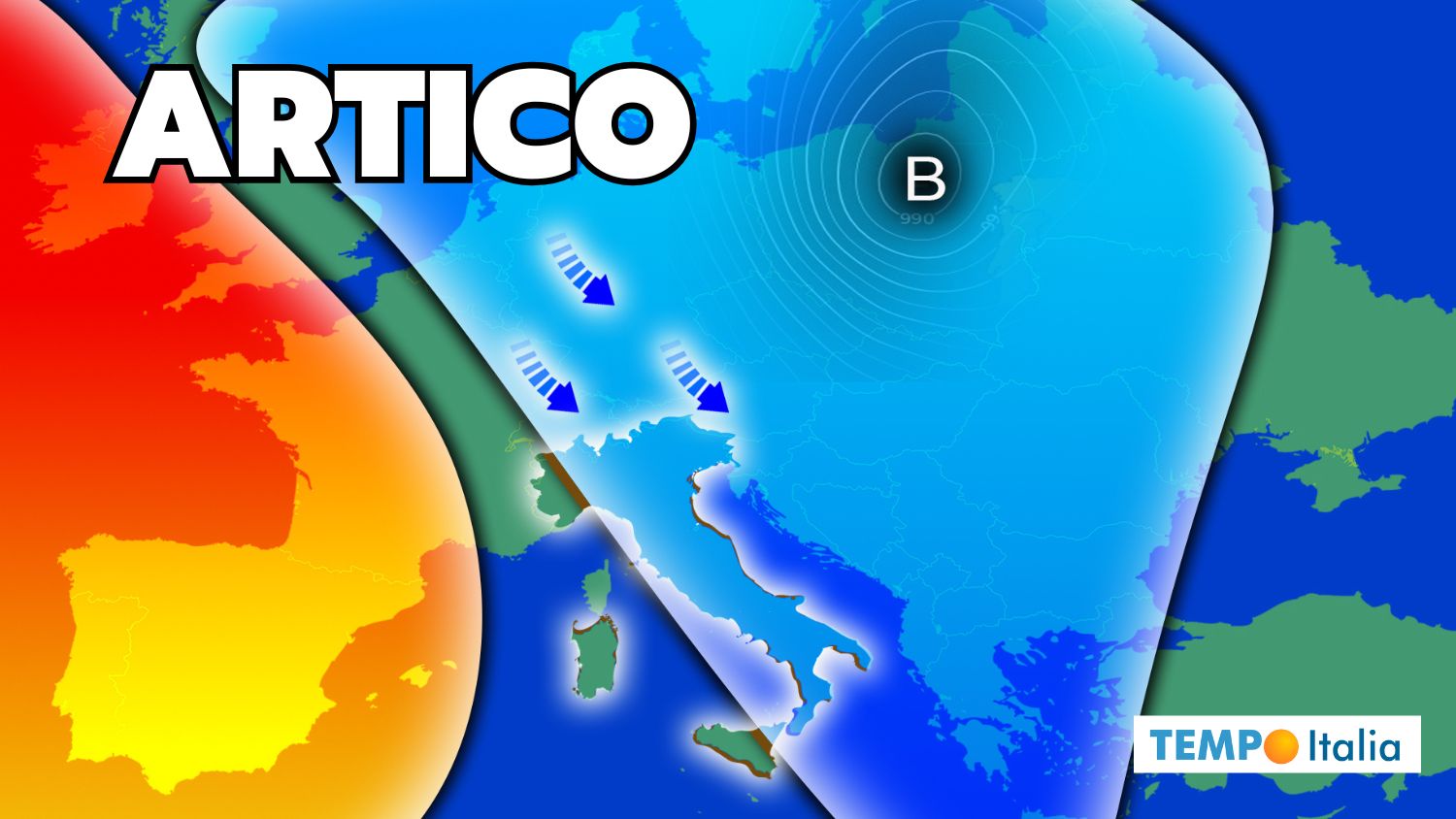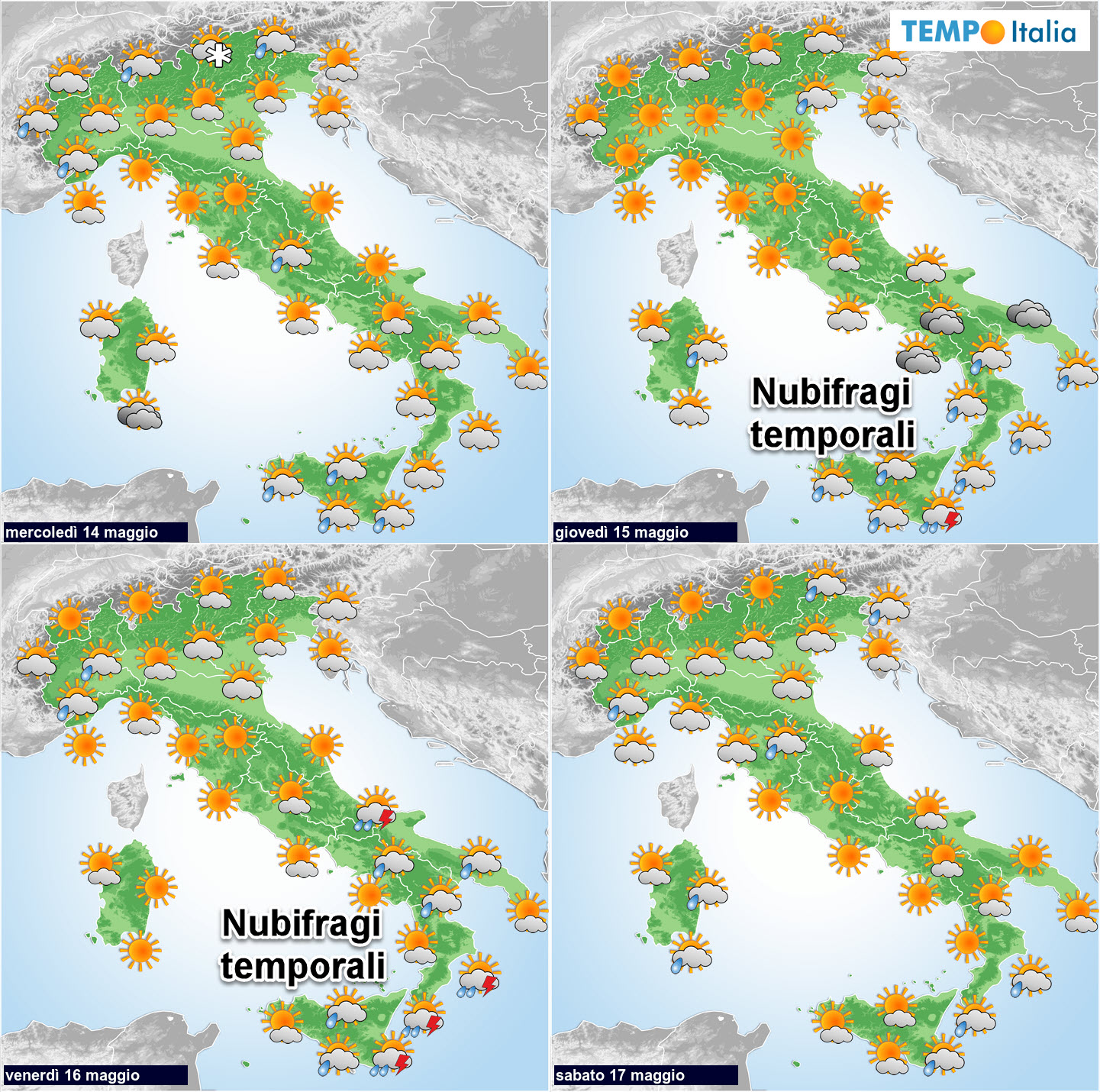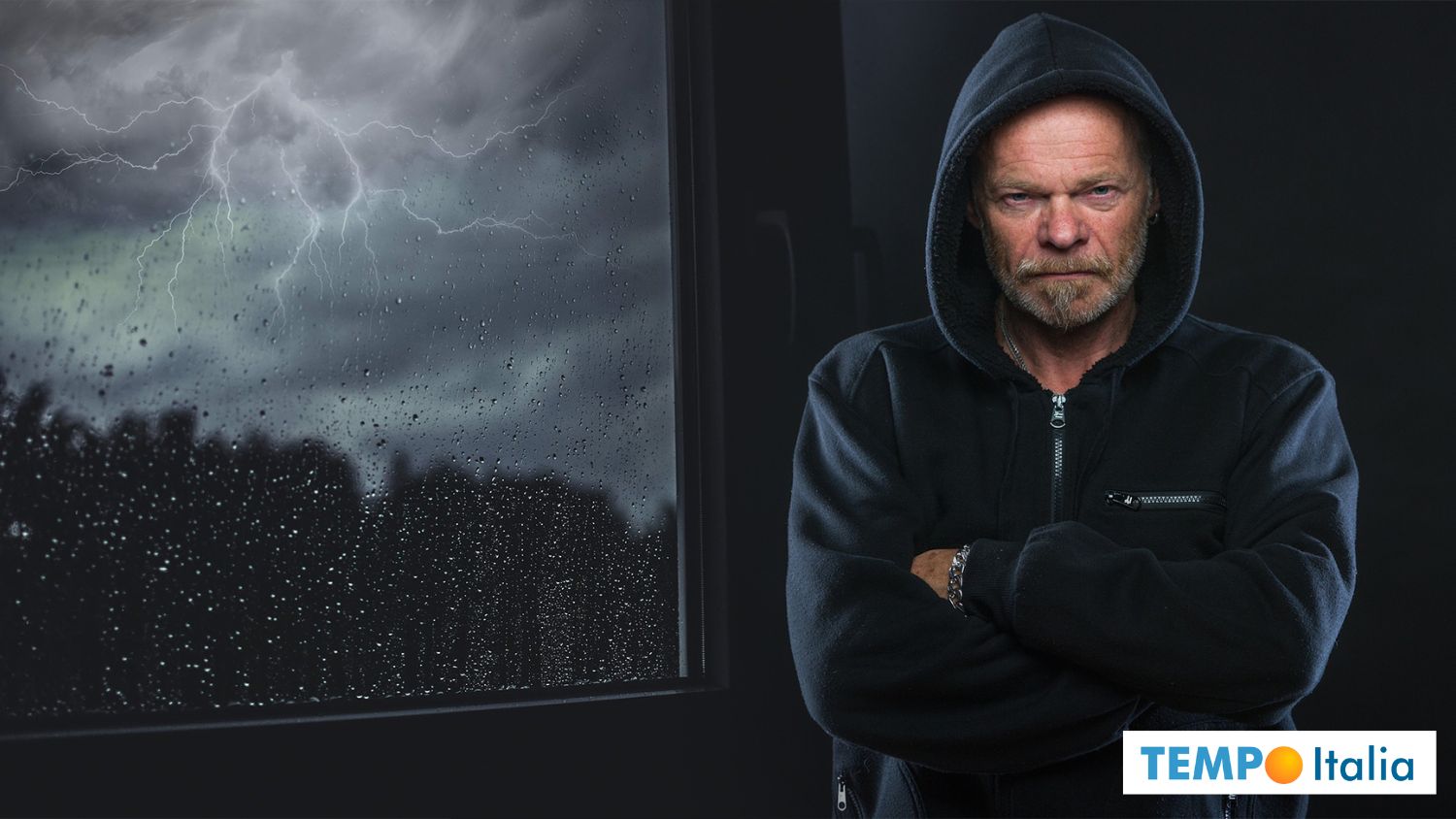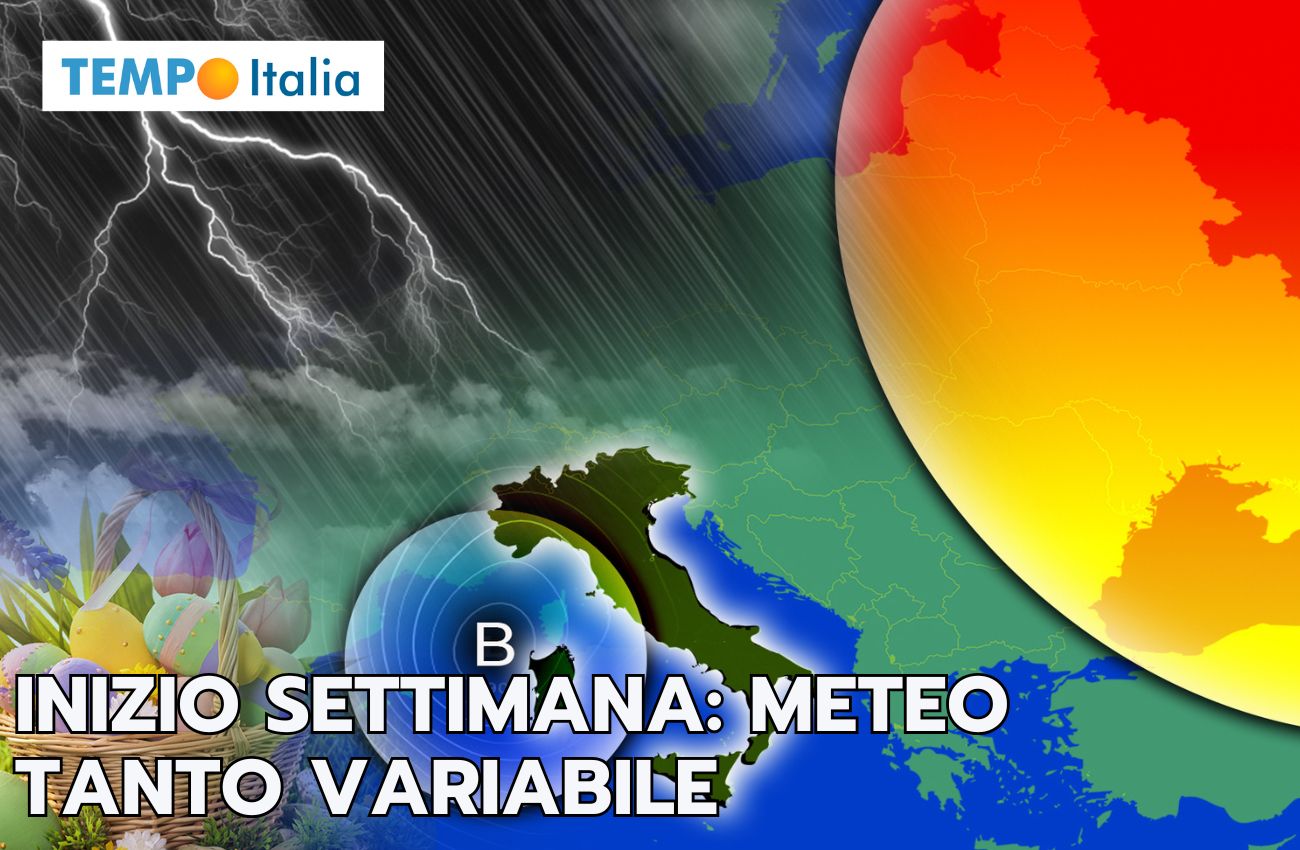Nel corso della sua lunga storia geologica, il
Vesuvio ha dato prova di un’attività estremamente variabile, alternando fasi di
quiescenza pluridecennali a periodi di intensa attività. L’evento più celebre e distruttivo rimane quello del
79 d.C., che ha dato origine a un’eruzione
pliniana, ma non va dimenticato il lungo ciclo eruttivo compreso tra il
1631 e il
1944, caratterizzato da
eruzioni stromboliane ed esplosive di varia entità. Secondo quanto riportato da
Cioni et al. (2008) nel
Journal of Volcanology and Geothermal Research, il comportamento storico del Vesuvio mostra una correlazione diretta tra
lunghezza della fase di quiescenza e
potenziale intensità dell’eruzione successiva (https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2008.11.015). Questo rende il vulcano un soggetto estremamente imprevedibile e pericoloso, specialmente considerando che l’ultima eruzione risale al
1944. Uno studio di
Neri et al. (2008), pubblicato su
Earth and Planetary Science Letters, identifica
quattro scenari principali sulla base dell’indice di esplosività vulcanica (
VEI, Volcanic Explosivity Index), adottando un criterio quantitativo utile per la pianificazione del rischio:
- Scenario effusivo (VEI 1-2): Colate laviche limitate e attività stromboliana.
- Scenario sub-pliniano moderato (VEI 3): Colonne eruttive fino a 15 km e ricadute localizzate.
- Scenario sub-pliniano violento (VEI 4): Colonne tra 15 e 25 km e presenza significativa di flussi piroclastici.
- Scenario pliniano (VEI 5+): Eruzioni catastrofiche con colonne superiori a 25 km, flussi su scala regionale e impatti globali.
Il
Piano Nazionale di Emergenza elaborato dalla
Protezione Civile italiana (aggiornato nel
2016) prende come riferimento un’eruzione
sub-pliniana violenta (VEI 4). Secondo le analisi di
Santacroce et al. (2008) sul
Bulletin of Volcanology, questo tipo di evento rappresenta una media statistica degli episodi storici più probabili per il Vesuvio (https://link.springer.com/article/10.1007/s00445-008-0213-0). Nel contesto di questo scenario, lo studio di
Mastrolorenzo et al. (2006) su
PNAS ha descritto gli
effetti attesi, che includono:
- Colonna eruttiva fino a 25 km di altezza
- Ricadute piroclastiche di circa 0,5 km³
- Flussi piroclastici con velocità superiori a 100 km/h
- Formazione di lahar e colate di fango nelle fasi post-eruttive (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0607477103)
Analisi degli impatti nei vari scenari Scenario effusivo (VEI 1-2): il meno distruttivo Uno scenario effusivo, secondo
Scandone et al. (2008), comporterebbe
colate laviche di limitata estensione che interesserebbero principalmente le
pendici meridionali del vulcano. Le conseguenze sarebbero:
- Evacuazioni localizzate
- Danni puntuali alle infrastrutture rurali
- Impatto minimo sulla rete urbana di Napoli
Tuttavia, anche una semplice colata potrebbe interrompere
reti stradali, elettriche e idriche, con effetti critici sul tessuto locale (https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2008.11.014).
Scenario sub-pliniano moderato (VEI 3): eventi più ampi e pericolosi Secondo
Zuccaro et al. (2008), un’eruzione VEI 3 causerebbe
ricadute di ceneri su un’area compresa tra
20 e 30 km dal cratere. Le aree urbane di
Portici,
Torre del Greco,
Ercolano,
San Giorgio a Cremano e
Napoli Est sarebbero esposte a:
- Flussi piroclastici localizzati
- Collasso strutturale dei tetti (oltre 150 kg/m² di cenere)
- Evacuazione di massa dell’intera zona rossa
(https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2008.05.011)
Scenario sub-pliniano violento (VEI 4): lo scenario ufficiale In questo contesto, lo studio di
Esposti Ongaro et al. (2008), pubblicato su
Journal of Geophysical Research, ha elaborato
modelli fisico-numerici per descrivere i flussi piroclastici:
- Velocità superiori a 80 km/h
- Temperature oltre i 400 °C
- Raggio d’azione fino a 10 km
- Ricadute di cenere fino a Napoli centro e oltre
(https://doi.org/10.1029/2007JB005074) Anche
Costa et al. (2012), su
Geophysical Research Letters, hanno dimostrato come i venti dominanti possano
trasportare la cenere fino a Roma, Bari e la Puglia, compromettendo
i voli aerei nel
Mediterraneo centrale (https://doi.org/10.1029/2011GL050477).
Scenario pliniano (VEI 5+): evento estremo È lo
scenario peggiore, simile a quello del
79 d.C.. Le ricerche di
Pareschi et al. (2006) indicano:
- Colonna eruttiva di oltre 30 km
- Espulsione di più di 5 km³ di tefra
- Flussi piroclastici fino a 20 km: la città di Napoli sarebbe a rischio diretto
- Effetti globali sul clima, con oscuramento parziale dell’atmosfera per settimane
(https://doi.org/10.1029/2006GL027790)
Fattori che determinano la violenza dell’eruzione Lo studio di
Acocella et al. (2015), su
Earth-Science Reviews, ha evidenziato
quattro fattori chiave:
- Durata della quiescenza: ogni anno di inattività aumenta l’accumulo di gas e pressione.
- Composizione del magma: più alto il contenuto in silice, maggiore l’esplosività.
- Quantità di gas: l’espansione rapida dei gas è alla base delle eruzioni esplosive.
- Presenza di acqua: la falda freatica può causare eruzioni freatomagmatiche, molto violente.
(https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.03.003) Anche
De Natale et al. (2016), in
Scientific Reports, hanno confermato la presenza di una
camera magmatica attiva a
8-10 km di profondità, in
lento processo di ricarica, monitorata in tempo reale dai sistemi dell’
INGV (https://doi.org/10.1038/srep34307).
Una minaccia concreta e in costante evoluzione Gli scenari descritti non sono ipotesi remote, ma
modelli previsionali basati su decenni di studio e tecnologie di sorveglianza avanzata. Il
Vesuvio, pur silenzioso da oltre 80 anni,
resta attivo, e ogni elemento del suo comportamento viene tracciato con rigore scientifico. La sfida futura non è solo
prevedere l’eruzione, ma
prepararsi a convivere con un sistema geologico che, prima o poi,
tornerà a manifestarsi.
Eruzione del Vesuvio, potenziali scenari

 Nel corso della sua lunga storia geologica, il Vesuvio ha dato prova di un’attività estremamente variabile, alternando fasi di quiescenza pluridecennali a periodi di intensa attività. L’evento più celebre e distruttivo rimane quello del 79 d.C., che ha dato origine a un’eruzione pliniana, ma non va dimenticato il lungo ciclo eruttivo compreso tra il 1631 e il 1944, caratterizzato da eruzioni stromboliane ed esplosive di varia entità. Secondo quanto riportato da Cioni et al. (2008) nel Journal of Volcanology and Geothermal Research, il comportamento storico del Vesuvio mostra una correlazione diretta tra lunghezza della fase di quiescenza e potenziale intensità dell’eruzione successiva (https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2008.11.015). Questo rende il vulcano un soggetto estremamente imprevedibile e pericoloso, specialmente considerando che l’ultima eruzione risale al 1944. Uno studio di Neri et al. (2008), pubblicato su Earth and Planetary Science Letters, identifica quattro scenari principali sulla base dell’indice di esplosività vulcanica (VEI, Volcanic Explosivity Index), adottando un criterio quantitativo utile per la pianificazione del rischio:
Nel corso della sua lunga storia geologica, il Vesuvio ha dato prova di un’attività estremamente variabile, alternando fasi di quiescenza pluridecennali a periodi di intensa attività. L’evento più celebre e distruttivo rimane quello del 79 d.C., che ha dato origine a un’eruzione pliniana, ma non va dimenticato il lungo ciclo eruttivo compreso tra il 1631 e il 1944, caratterizzato da eruzioni stromboliane ed esplosive di varia entità. Secondo quanto riportato da Cioni et al. (2008) nel Journal of Volcanology and Geothermal Research, il comportamento storico del Vesuvio mostra una correlazione diretta tra lunghezza della fase di quiescenza e potenziale intensità dell’eruzione successiva (https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2008.11.015). Questo rende il vulcano un soggetto estremamente imprevedibile e pericoloso, specialmente considerando che l’ultima eruzione risale al 1944. Uno studio di Neri et al. (2008), pubblicato su Earth and Planetary Science Letters, identifica quattro scenari principali sulla base dell’indice di esplosività vulcanica (VEI, Volcanic Explosivity Index), adottando un criterio quantitativo utile per la pianificazione del rischio: 


















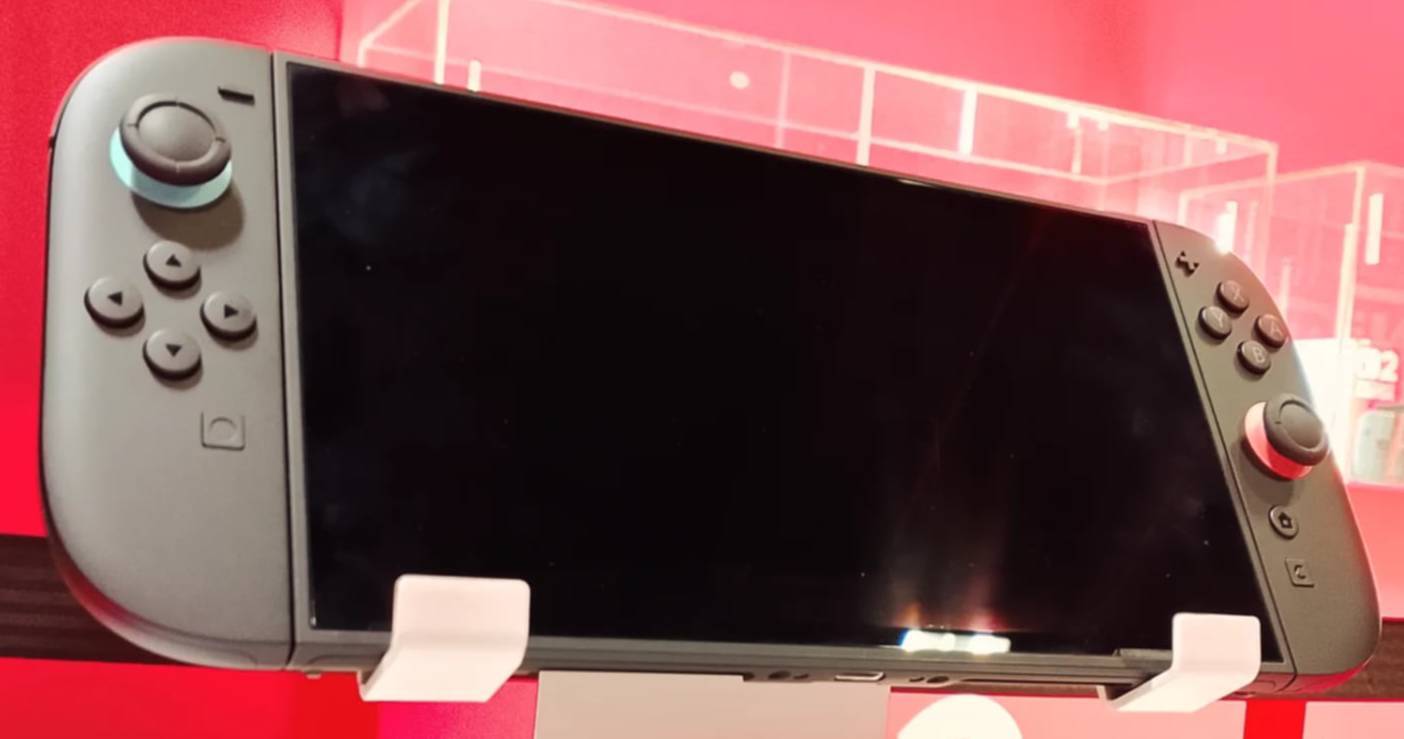









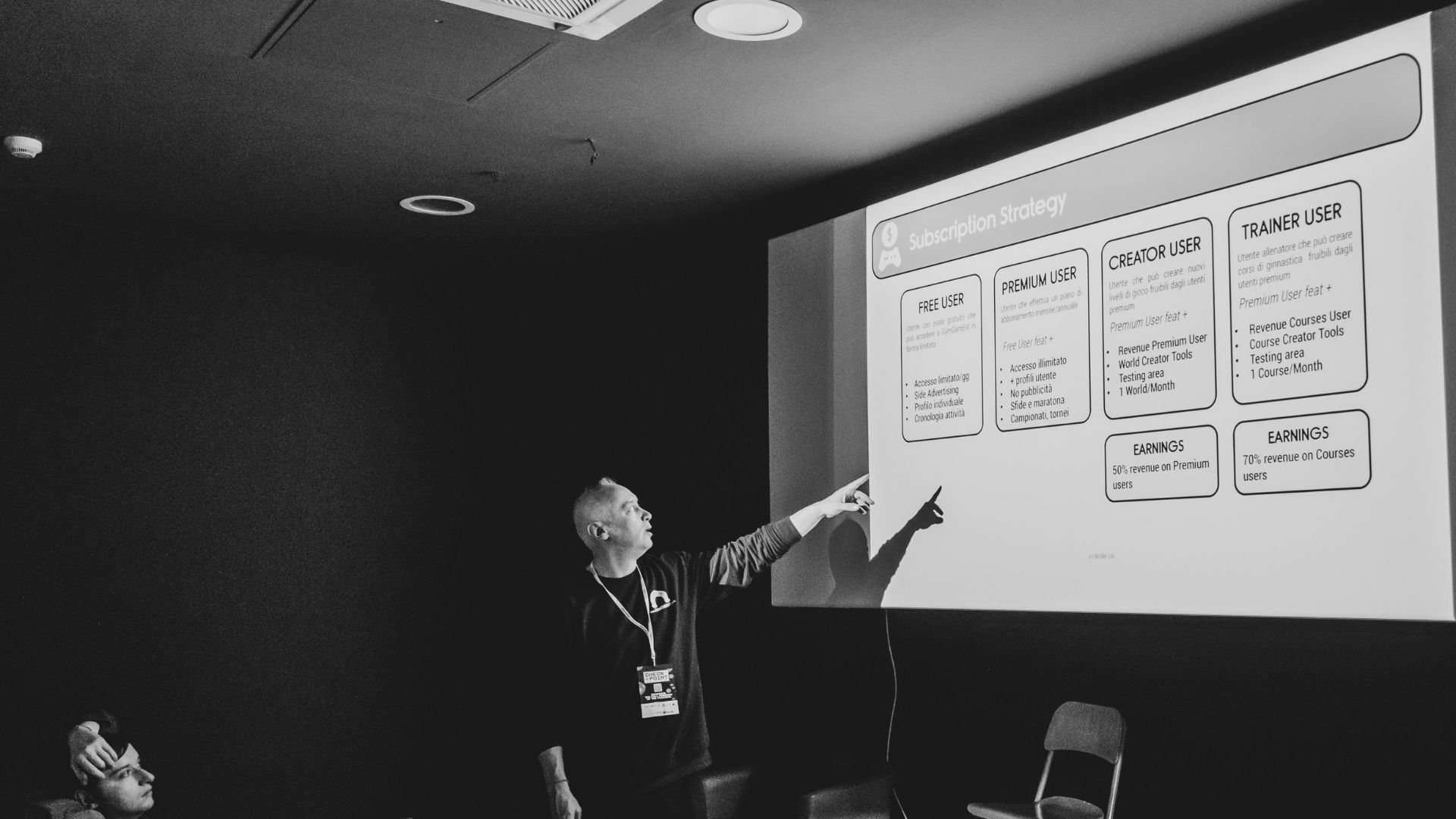
































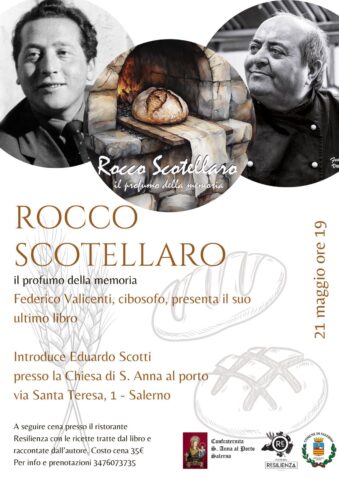





















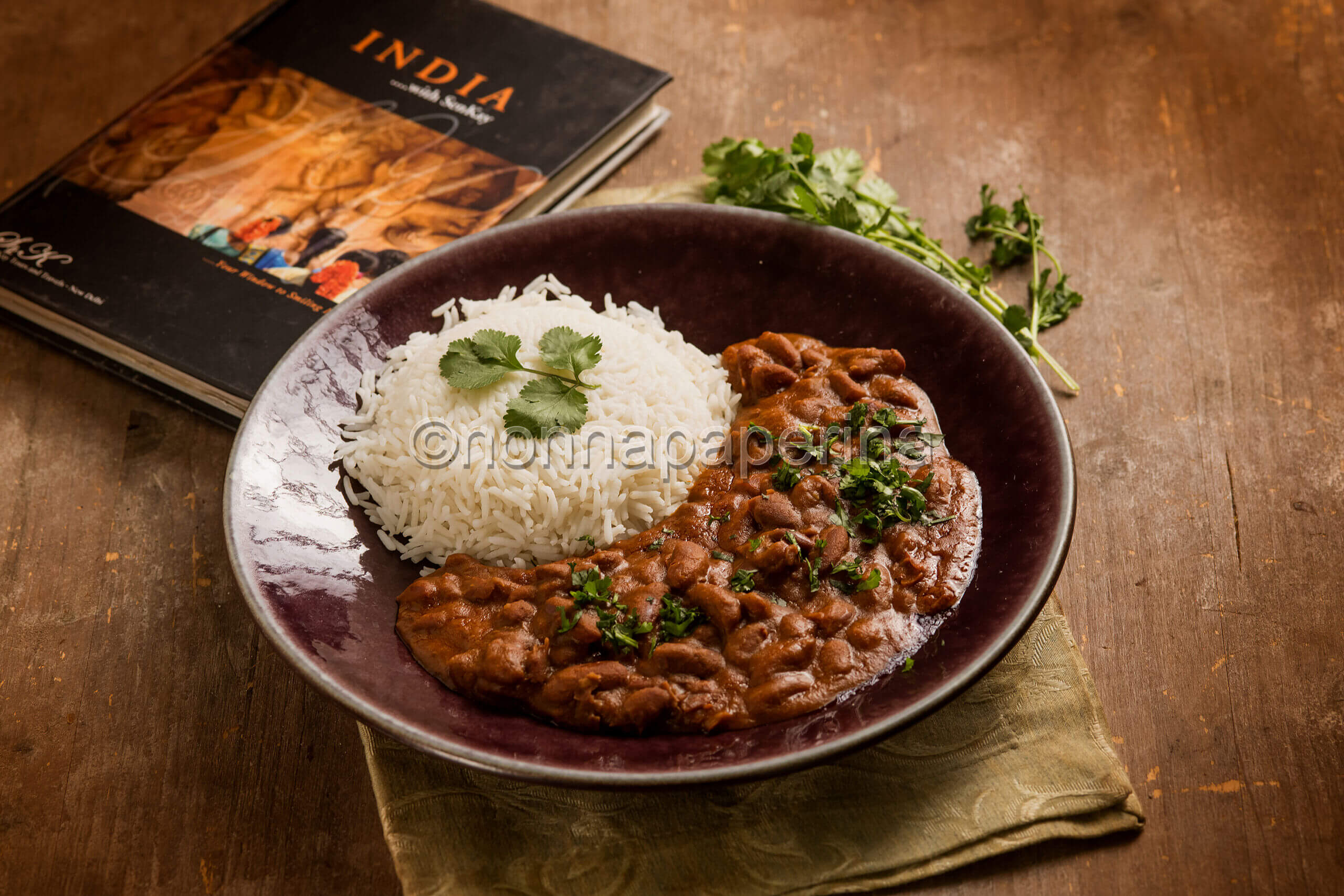






























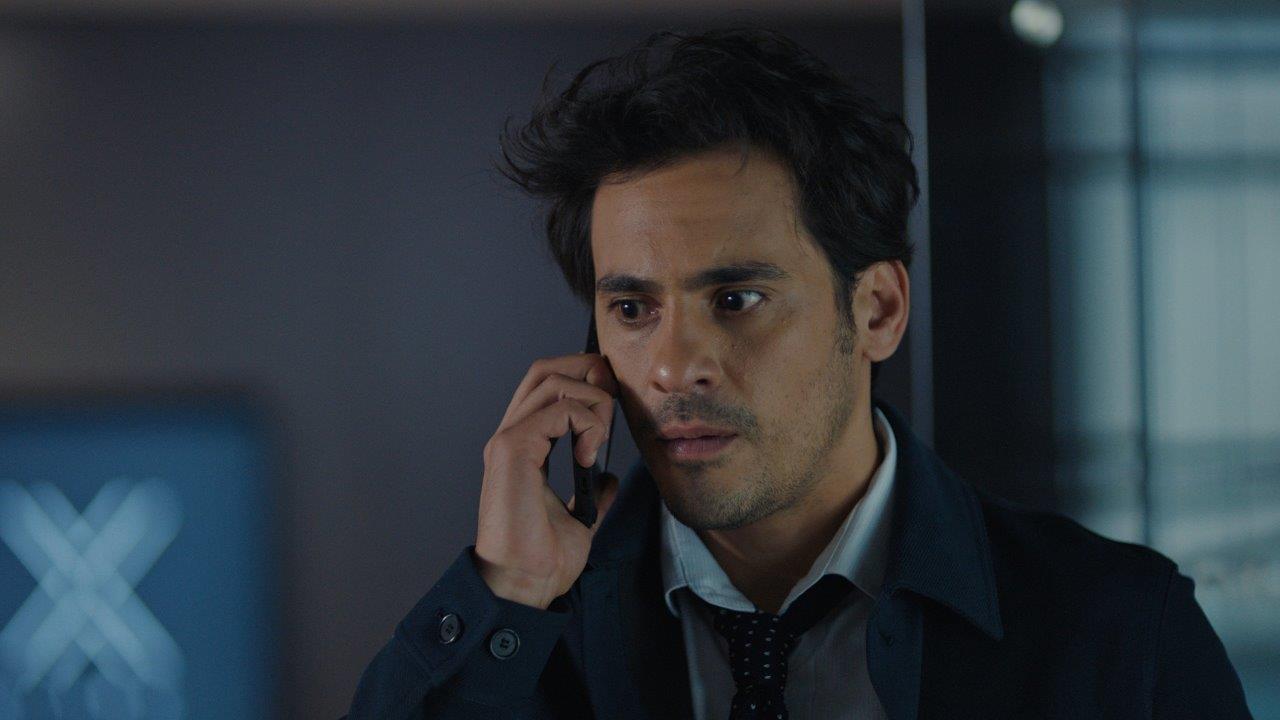



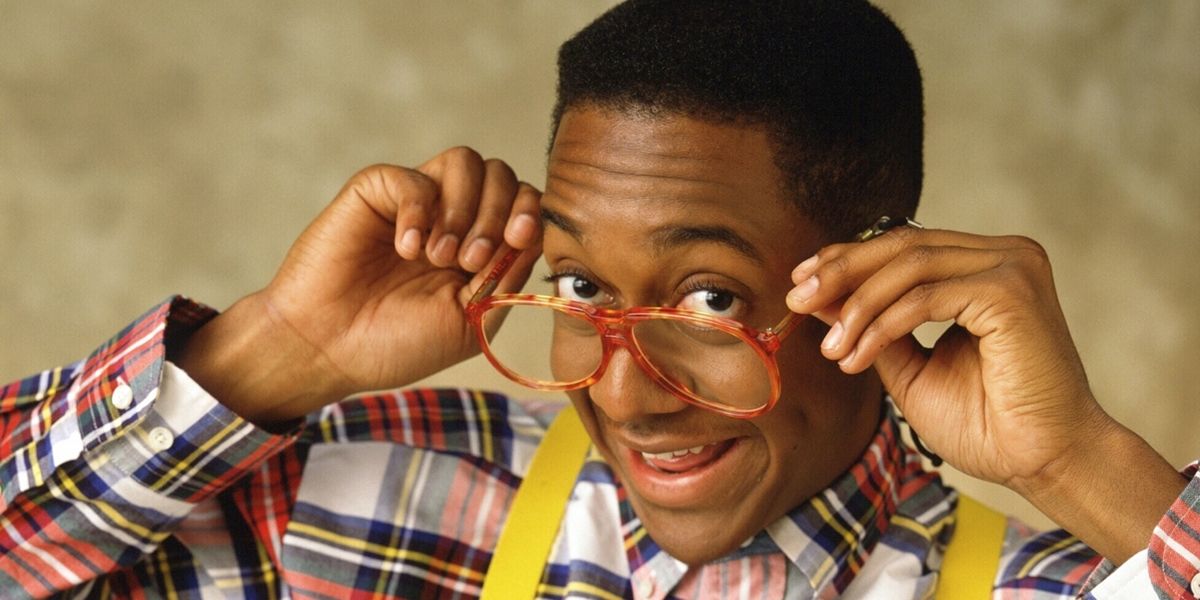








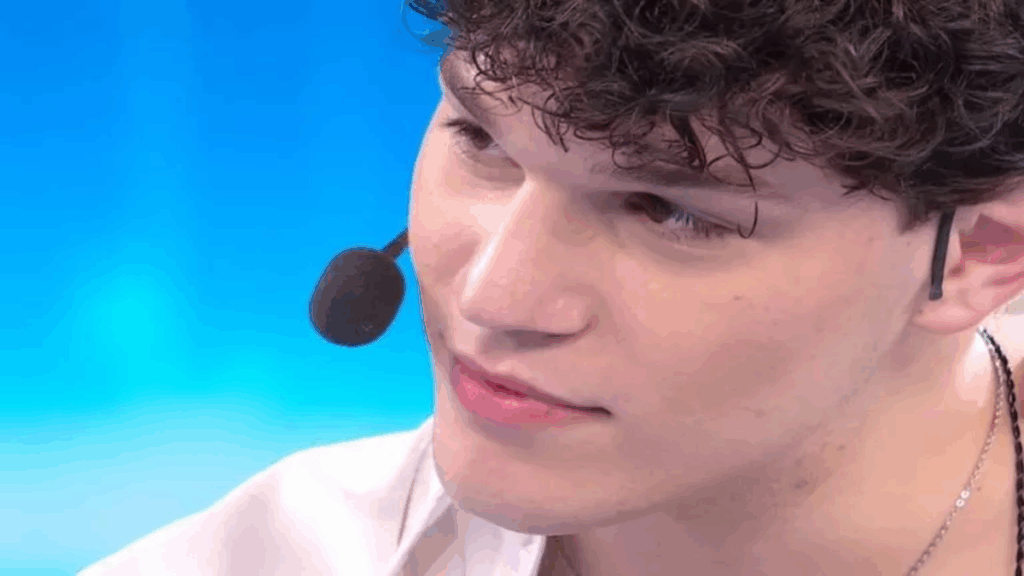

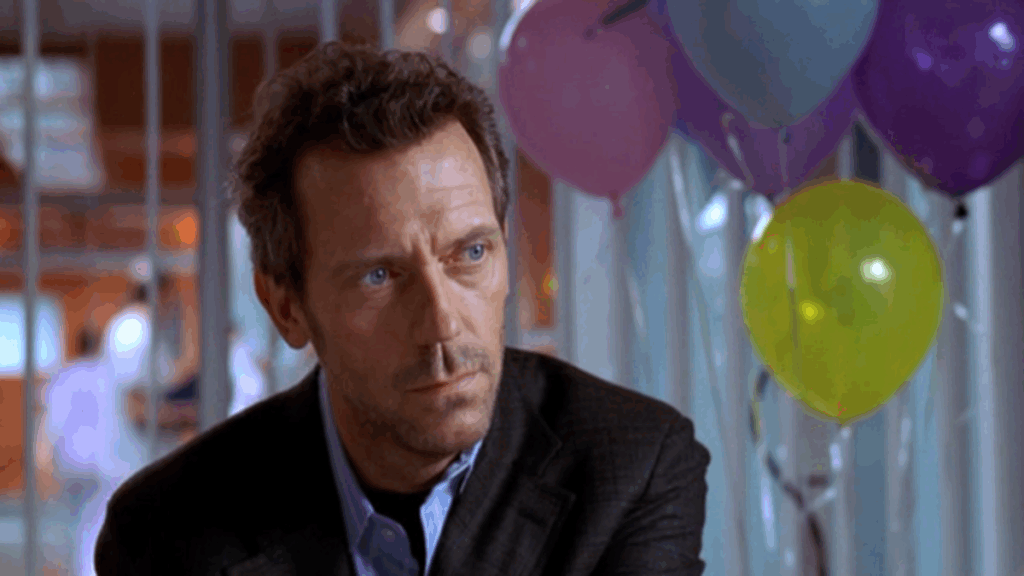

















![Il 2026 sarà un anno d’oro per l’horror, con l’uscita di 12 nuovi titoli attesissimi: ecco quali [LISTA]](https://www.lascimmiapensa.com/wp-content/uploads/2025/05/image-121.png)

![The Office: la prima immagine di The Paper, il sequel/spin-off con Domhnall Gleeson [FOTO]](https://www.lascimmiapensa.com/wp-content/uploads/2025/05/image-112.png)