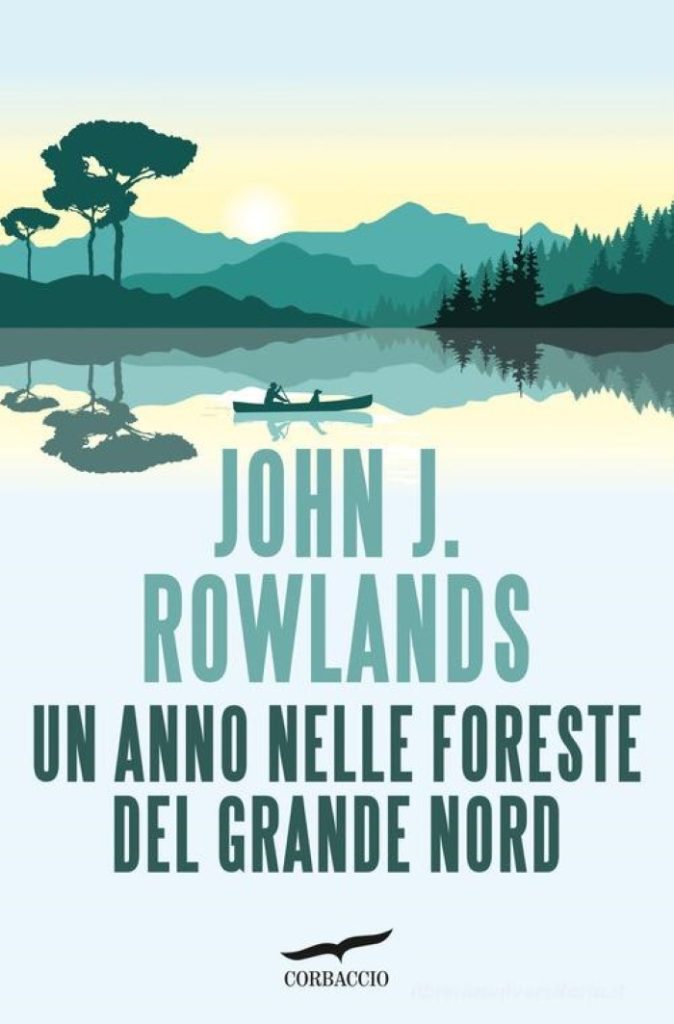La vera wilderness ci ucciderebbe
Tanti discorsi, tanti sogni. Ma saremmo davvero in grado di sopravvivere nella natura non addomesticata? O, almeno, per quanto tempo? L'articolo La vera wilderness ci ucciderebbe proviene da Montagna.TV.


“Questa città è una jungla”. Quante volte nel corso di una settimana mi trovo a pensare questa frase un po’ cinematografica! Ogni volta, per esempio, che imbocco una pista ciclabile, sul mio cavallo di ferro, e sfido rider e automobilisti indisciplinati, o vado al supermercato a fare la spesa di sabato, o cerco di concedermi un bis pizza/cinema senza aver prenotato entrambi su qualche app. La vita nelle nostre metropoli, penso, è diventata davvero complicata e faticosa, e “ci vuole un fisico bestiale”, o quanto meno un corso di sopravvivenza urbana, per uscirne vivi.
La realtà però è un’altra. Noi umani del terzo millennio sguazziamo nella vita cittadina come delfini all’acquapark, mentre siamo ormai del tutto inadatti alla vita nella natura. E per natura intendo quella vera, senza sconti, mica la wilderness addomesticata delle nostre Alpi. Intendiamoci: un bravo alpinista, un bravo escursionista, saranno sempre più preparati di un medio cittadino indoor (ufficio, casa, palestra… bar). Ma mettili nelle foreste canadesi, in mezzo ai grizzly: quanto sopravvivrebbero? Questa è la prima domanda che mi sono fatto quando ho preso in mano il delizioso libro di John F. Rowlands tradotto da Corbaccio a quasi settant’anni dalla prima edizione. Si intitola Un anno nelle foreste del Grande Nord e a prima vista sembra il manuale delle Giovani Marmotte: pieno di disegni di animali e impronte di animali, strumenti da fabbricare con pochi mezzi, piante e foglie, mezzi di trasporto naturali (sostanzialmente due: le gambe e le canoe), situazioni di sopravvivenza estrema. Ma non lasciatevi trarre in inganno: lo scopo dell’autore non è di insegnarci a vivere come i nativi americani, il suo scopo è scrivere l’epopea della wilderness autentica. E a mio parere ci è pienamente riuscito.
Due parole sull’autore: nato nel 1882 nel North Carolina e morto a Boston novant’anni dopo, non era un trapper ma un giornalista, figlio di un dirigente di una compagnia di legname. Proprio seguendo il lavoro del padre, Rowland cresce tra foreste e miniere dell’Ontario, frequenta una scuola militare e nell’autunno del 1911 intraprende un viaggio di cento miglia sulle piste forestali per testare un veicolo militare, accompagnato da una guida indiana, il capo Tibeash della tribù Cree, di cui diventa intimo amico. Nei cinque anni successivi, Tibeash gli insegna molto sulle tecniche di sopravvivenza indiane e gli fornisce le basi per quello che decenni più tardi sarà il suo capolavoro letterario.
Non è un manuale, dicevamo, ma non è nemmeno un saggio: Un anno nelle foreste del Grande Nord è uno strano ibrido di fiction, istruzioni per l’uso e poesia. Tutto si svolge in dodici capitoli, uno per mese dell’anno, attorno al Lago Cache, sul 47esimo parallelo. Qui John ha costruito la sua casetta di legno, quella del Capo Tibeash si trova sul vicino Lago Albero Splendente, quella di Hank (un botanico-eremita) sul Lago Coda di Castoro. I tre, mese dopo mese, stagione dopo stagione, vivono insieme una quantità di micro-avventure, pescano nel lago ghiacciato e cacciano l’orso, costruiscono pagaie e mobili, tende e slitte, forni e ghiacciaie, osservano la vita delle oche selvagge e delle alci, navigano e camminano, si difendono dal freddo (fino a -40 °C) e dalle zanzare estive, impastano torte e cavano la linfa dagli aceri per farne sciroppo e zucchero, cantano e ridono e discutono, ma stanno anche molto in silenzio. L’unica cosa che non fanno mai è usare il denaro. (Anche le donne sono scarsine in questo libro, ma i tre protagonisti non se ne fanno un problema).
Ognuna di queste attività è descritta con ricchezza di particolari e notazioni tecniche, tanto da farci credere di poterle riprodurre. Ma è un’illusione, non ci riusciremmo mai, e sicuramente non riusciremmo a rimanere vivi, in quella magica wilderness canadese, per più di una settimana. E tuttavia questo libro è una boccata d’ossigeno, per noi cittadini impenitenti: ci racconta di una natura che forse non esiste più nemmeno nel Grande Nord, ci porta in territori talmente immensi e selvaggi che, a confronto, rendono i nostri parchi nazionali poco più di zoo recintati. Insomma, ci fa sognare. E purtroppo, ci mette davanti ai nostri limiti. D’ora in poi, ogni volta che mi metterò in cammino su un sentiero (segnalato dal CAI) penserò al saggio Capo Tibeash e alla sua soprannaturale abilità di orientarsi, leggendo i segni sul terreno e nelle stelle. Ma questo non mi impedirà, come spesso accade, di continuare a perdermi.
L'articolo La vera wilderness ci ucciderebbe proviene da Montagna.TV.





























































































































![Hayao Miyazaki contro l’arte generata da I.A.: “Sono completamente disgustato” [VIDEO]](https://www.lascimmiapensa.com/wp-content/uploads/2025/03/image-303.png)